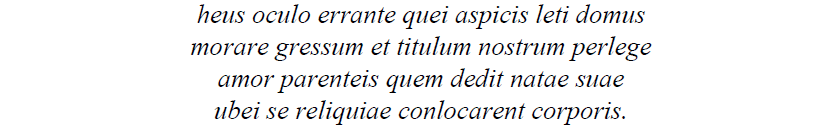
Emanuele Castelli
Titulus.
Un contributo alla storia della parola
nel mondo romano*
Friedrich August Wolf scrisse nel 1795 che in linguis verba manent, significationes flectuntur ad temporum et rerum vicissitudines [1] . Il famoso studioso di Omero espresse in tal modo un concetto fondamentale: anche le parole hanno una storia. Se infatti sul piano morfologico possono conservarsi le stesse persino per secoli e secoli, su quello semantico tendono a una inesorabile evoluzione, in rapporto alle trasformazioni della società. Ma la storia di un vocabolo si risolve solo qualche volta nel graduale passaggio da un significato a un altro. Molto spesso il processo è più complesso. Accade infatti che un dato termine assuma nel corso del tempo nuovi valori, senza per questo perdere quello o quelli precedentemente avuti. Usi diversi si sedimentano quindi, senza escludersi a vicenda. La parola finisce così per potere essere adottata ora in un senso ora in un altro, a seconda delle necessità espressive dei parlanti.
È quanto avvenuto col lat. titulus. Lo spettro eccezionalmente ampio dei suoi significati è cosa nota, nelle sue linee generali, a chi si occupa di scienze dell’antichità. Tuttavia, il tentativo di delineare un quadro completo delle realtà indicate (e dei concetti espressi) nel mondo romano per mezzo di tale parola non è stato ancora compiuto. Una tale indagine è stata a lungo ostacolata da diversi fattori, quali la vertiginosa quantità di occorrenze da vagliare, sparse dovunque nella documentazione pervenuta, e la prolungata mancanza di idonei strumenti di ricerca. Sino a oggi sono stati così compiuti solo sondaggi. L’accertamento dei valori librari di titulus è stato forse l’aspetto che più ha assorbito le energie dei filologi [2]. Un certo interesse è stato anche mostrato per le accezioni giuridiche della parola [3]. Minore attenzione è stata invece concessa a quelle assunte in ambito ecclesiastico tra tardoantico e altomedioevo[4] . Ma sono soprattutto gli usi di titulus in rapporto ad aspetti e realtà di carattere epigrafico i meno studiati. Già cinquant’anni fa Giancarlo Susini costatava, in un famoso lavoro, l’impossibilità di tradurre titulus sempre e comunque, o in modo sommario, come «iscrizione»[5]. L’approfondimento di questo aspetto della storia della parola è ancora un desideratum.
Sussistono però oggi condizioni favorevoli per la raccolta e l’analisi di una materia tanto dispersa. Un censimento delle occorrenze del termine latino può ora fondarsi su risorse elettroniche contenenti tutto o quasi ciò che è giunto sino a noi della lingua dei Romani. Notevoli progressi sono stati compiuti nell’ultimo periodo in special modo per la registrazione informatica del lessico presente nella documentazione epigrafica[6]. È recentissima, poi, la pubblicazione degli indici completi dei fascicoli di CIL I2, cioè della raccolta di tutte le iscrizioni latine anteriori alla morte di Cesare [7]. La possibilità di vagliare sistematicamente tutte le attestazioni del termine latino, e così di esplorarne con precisione la storia, gli usi, i significati, si è fatta concreta.
È opportuno anzitutto circoscrivere, sul piano cronologico, il perimetro entro il quale si muoverà la presente indagine. Lasciata da parte la discussa notizia, secondo la quale il poeta Afranio, attivo tra II e I secolo a.C., sarebbe stato autore di una commedia chiamata Titulus [8], va messo in evidenza che nella documentazione pervenuta la parola fa le sue prime apparizioni solo verso la fine dell’età repubblicana. Le occorrenze di questo primo periodo sono tuttavia poche e problematiche da vari punti di vista [9].
In CIL I2 titulus è attestato solo due volte, anzitutto in CIL I2 1214, dove si leggono, dopo i dati biometrici della defunta — una fanciulla di nome Eucharis Licinia, morta all’età di quattordici anni — queste parole:
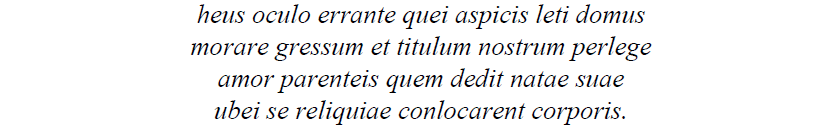
Seguono altri versi, in cui la defunta racconta di sé, dell’educazione ricevuta e del pianto lasciato al genitore con la propria scomparsa [10]. Il testo appena citato è stato oggetto di molto interesse da parte dei moderni tra l’altro per la presenza del termine titulus, qui generalmente inteso nel senso di «iscrizione» o «epitafio» [11], sebbene non si possa escludere già per questa prima occorrenza un significato più generale. È infatti possibile che la parola sia stata usata per indicare l’intero monumento epigrafico, la lapide funeraria, dunque, intesa qui come monumento iscritto, fatto collocare dal genitore sul luogo di sepoltura della figliola [12].
Sulla esatta cronologia di questo prodotto epigrafico pesano comunque alcune incertezze. La datazione al I secolo a.C. proposta dal Bücheler e dal Mommsen, condivisa da Heikki Solin e da Matteo Massaro, non è accolta da altri studiosi, che si pronunciano per il I o II secolo d.C. [13].
Nessuna obiezione è stata invece mossa contro la datazione di CIL I 2 2123, un prodotto epigrafico di area sarsinate assegnato tra gli altri da Susini alla metà del I secolo a.C. Il testo è di estremo interesse. In esso s’informa sulla concessione, da parte di Horatius Balbus [14], di un terreno per la sepoltura di persone meno abbienti, ma non immeritevoli. Il terreno era collocato
![]()
Queste le coordinate geografiche del fondo e converrà rilevare che esse sono poco chiare proprio nel punto che più ci interessa. In che cosa propriamente consisteva il titulus superior ricordato nell’iscrizione? Si trattava di una stele collocata in un punto più elevato dell’area? Di una semplice iscrizione segnata, alla fine del fondo, su di un muro? O soltanto di un segnacolo? I moderni si sono interrogati a dovere. Ma poiché l’originario contesto di questa iscrizione è ignoto, non si è data risposta sicura alla questione [15].
Le carenze della documentazione di questo periodo non sono colmate da altre iscrizioni in nostro possesso, come quella edita da Paola Friggeri nel 1991 (AE 1991, 103), dove si legge:
![]()
L’epigrafe, edita in una raccolta di Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, potrebbe in realtà facilmente appartenere agli inizi dell’età imperiale [16].
Un’antica occorrenza della parola potrebbe invece essere individuata in IG XIV 297 = CIL X 7296, l’insegna bilingue di una bottega lapidaria siciliana divenuta famosa nella scienza epigrafica grazie agli studi di Jean Mallon [17]. Nella colonna latina, righe 1–4, si leggono le seguenti parole:
![]()
Sulla corrispettiva colonna greca si legge invece στῆλαι ǀ ἐνθάδε ǀ τυποῦνται καὶ ǀ χαράσσονται… . Anche la cronologia di questo prodotto epigrafico rimane, in ogni caso, incerta. La datazione al I secolo a.C. proposta da Géza Alföldy è stata considerata troppo precoce da altri studiosi, che propendono almeno per il secolo successivo [18]. Sul testo latino, come sul corrispettivo greco, di questa insegna gravano comunque alcune questioni di carattere ermeneutico e in particolare il significato di titulus risulta di non semplice interpretazione. Secondo il già ricordato Mallon, nell’iscrizione sarebbero indicate due fasi fondamentali della produzione di testi epigrafici su pietra: la loro mise en page, «en signes épigraphiques», compiuta «à la craie ou au charbon ou à la pointe sèche»; e la «gravure» [19]. Titulus sarebbe dunque stato usato in riferimento ai testi da iscrivere, mentre il verbo ordinari esprimerebbe l’operazione di mise en page sul supporto lapidario. Pertanto, l’iscrizione sarebbe da intendere così: «qui si impaginano e si incidono iscrizioni … » [20]. Alla stessa maniera si dovrebbe intendere la parte greca [21].
In realtà, è difficile ammettere che l’insegna possa avere avuto lo scopo e il significato sostenuti dal Mallon. Piuttosto per mezzo di essa si sarà voluto semplicemente segnalare al pubblico una duplice e in parte diversa attività della bottega lapidaria: la conveniente lavorazione dei supporti lapidari, in modo da ricavarne monumenti di forme e dimensioni adeguate alla destinazione prevista (= templi o edifici pubblici), e la loro successiva iscrizione[22]. In questa prospettiva ermeneutica, mi sembra chiaro che tituli sia da interpretare in senso ben diverso da quello comunemente accolto. La parola designa in questo caso i semplici supporti lapidari da modellare e ancora da iscrivere. Lo stesso vale per στῆλαι.
Come visto, le occorrenze di titulus in questi primi prodotti epigrafici costituiscono un insieme assai scarno e per vari aspetti problematico. Il quadro di dati sopra fornito, del resto, è arricchito solo in minima parte dalla più o meno coeva documentazione letteraria [23], che si può passare in rassegna con maggiore rapidità, essendo stata già vagliata in utili lavori [24].
È nella prosa di Cicerone che la parola fa le sue prime sicure apparizioni. Il celebre oratore romano si serve tuttavia di titulus in due sole occasioni: in riferimento alla dignità del consolato [25] e parlando di coloro che consideravano il nome di sapiente come un appellativo d’onore [26]. Qualche altra occorrenza compare poi in Orazio (65 a.C.–8 a.C.) e in Properzio (47 a.C.–14 a.C.), poeti che già conobbero l’età di Augusto. Nei versi del primo il termine è presente tre volte: in riferimento a realtà epigrafiche destinate a eternare la fama dell’imperatore, in relazione alle iscrizioni che corredavano le immagini degli antenati, in senso traslato [27]. In quelli di Properzio è invece usato quattro volte come denominazione di targhe celebrative e propagandistiche o ancora per indicare cartelli a carattere commerciale[28]. Nelle elegie di Tibullo (circa 50 a.C.–19 a.C.) è invece attestato, se non erro, una sola volta, a proposito della messa in vendita dei beni del poeta [29].
Titulus riceve comunque piena cittadinanza nella letteratura latina con due altri autori dell’età augustea: Tito Livio (59 a.C.–17 d.C.) e Ovidio (43 a.C.–18 d.C). Il primo se ne serve almeno 37 volte [30], il secondo in 57 occasioni[31]. Soprattutto con questo poeta si manifesta un altro dato notevole, che caratterizzerà tutta la storia successiva della parola: l’eccezionale molteplicità dei suoi significati. Ovidio utilizza, infatti, titulus in contesti e con accezioni anche nettamente differenti tra loro, ora a proposito di realtà epigrafiche, ora in merito ad aspetti librari, ora in senso traslato. Anche nella documentazione epigrafica le attestazioni si fanno più consistenti con l’avvento dell’età imperiale [32].
L’uso del termine latino sperimenta dunque n el corso dell’età augustea un vero e proprio exploit a livello quantitativo e qualitativo. Da questo momento in avanti, la parola è ininterrottamente adottata, per tutta l’età antica, in svariati contesti e in differenti accezioni. E così trapassa nel latino medievale.
Indagini sistematiche sui significati di titulus sono state compiute da chi scrive solo per l’epoca romana e in ogni caso non oltre il VI secolo d.C. Considerata, d’altra parte, l’eccezionale varietà di usi ( epigrafici, librari, giuridici, ecclesiastici e altro ancora) assunti dalla parola nel corso di questo lungo periodo, non sarà possibile censirli e illustrarli tutti in questa sola occasione. È necessaria una scelta di campo. Nel corso di questo lavoro mi impegnerò dunque essenzialmente a esplorare e definire le accezioni epigrafiche di titulus. Intendo, cioè, chiarire che cosa la parola, se riferita ad aspetti e realtà di carattere epigrafico, poteva propriamente designare.
In effetti, occorre subito premettere che il ventaglio di significati assunti dal termine latino in relazione a tali aspetti è certamente molto più ampio e sfaccettato di quanto generalmente si pensi [33] . La parola risulta infatti usata:
a. in riferimento al solo supporto destinato ad accogliere l’iscrizione e in particolare:
– nel senso di superficie piatta ;
– oppure col significato di lastra o lapide destinata alla scrittura epigrafica, ma non ancora da questa corredata.
b. del tutto all’opposto, col significato di testo iscritto , dunque col valore di scrittura esposta (o displayed writing ) [34] , ossia di pura e semplice iscrizione, a prescindere dal supporto materiale che la accoglie;
c. per indicare il prodotto iscritto nel suo complesso e cioè:
– la superficie già iscritta;
– oppure quel genere di cartelli che si esponevano a Roma in occasione dei trionfi militari o per altre occasioni, i cosiddetti tituli praelati , sui quali erano indicate informazioni di vario genere e di pubblico interesse;
– o ancora nel senso di lastra, lapide o tabella, stele, ara e altro monumento già corredato di iscrizione. In tali casi il termine è dunque usato per indicare appunto il monumento epigrafico nella suo insieme.
Non rimane ora che illustrare tali valori uno per uno. Mi concentrerò subito sull’uso di titulus come denominazione della sola superficie o della lastra destinata all’iscrizione, cioè sugli usi in assoluto meno noti e considerati negli studi contemporanei. Passerò poi a occuparmi degli altri. Per documentare i significati appena elencati saranno prese in esame, naturalmente, occorrenze della parola tanto nei testi letterari quanto in quelli propriamente epigrafici.
È utile qui precisare in che senso mi servirò del termine « iscrizione ». Negli studi contemporanei esso è usato talvolta in senso stretto, per indicare la sola scrittura epigrafica, il testo iscritto, altre volte in senso più ampio, in riferimento all’intero monumento epigrafico. Per parte mia, me ne servirò sempre nel primo dei due sensi . I vantaggi di questa delimitazione saranno a breve evidenti e consistono soprattutto nella possibilità di fare coincidere l’uso della parola italiana con uno dei possibili valori di titulus .
Con l’apparizione del saggio di Susini su Il lapicida romano [35] si inaugurò, nel 1966, una fase di rivalutazione di alcuni testi epigrafici, la cui interpretazione non sembrava dovesse più offrire alcuna novità. Invece Susini richiamò nuovamente l’attenzione su CIL III 633, 1 e CIL III 633, 2 : due iscrizioni rupestri relative al culto di Silvano a Filippi, datate da Paul Collart al II secolo d.C. [36] . Nell’una come nell’altra è notevole l’uso di titulus . La parola è infatti riferita non al testo iscritto, ma alla sola superficie destinata ad accoglierlo [37] .
Così, in effetti, si legge in CIL III 633, 1:P(ublius) Hostilius Philadelphus ǀ ob honor(em) aedilit(atis) titulum polivit ǀ de suo et nomina sodal(ium) inscripsit eorum ǀ qui munera posuerunt … .
Il senso di questo passo è chiaro. Publio Ostilio Filadelfo aveva provveduto alla necessaria delimitazione, levigatura e riquadratura della superficie (della parete rocciosa) destinata all’iscrizione del nome dei solidali. Il termine titulus indica qui proprio quella parte del supporto lapidario ridotta a superficie idonea per la scrittura epigrafica.
CIL III 633, 2, si apre, invece, con le seguenti parole:

Qui è messa in evidenza un’operazione addirittura antecedente alla stessa politura della superficie epigrafica. Si tratta del taglio della parte inferiore della parete rocciosa, compiuto allo scopo di ricavare la superficie da lavorare e da iscrivere, il titulus appunto. Anche in questo caso, comunque, Publio Ostilio non voleva fare altro che insistere sulle modalità di produzione dello spazio riservato alla scrittura epigrafica.
Se dovessi proporre una traduzione delle parole iniziali di tale iscrizione, direi pertanto che Publio Ostilio Filadelfo «tagliò la pietra nella parte inferiore e ne fece [ossia: ne ricavò, evidentemente dopo la necessaria levigatura] la superficie [qui appunto nel senso di specchio epigrafico], dove scrisse e scolpì i nomi degli adepti … » con quel che segue.
Come si vede, CIL III 633, 1–2, costituiscono due puntuali testimonianze di età imperiale relative all’impiego di titulus come denominazione della superficie destinata all’iscrizione. Altrove la parola è invece utilizzata, in senso più generale, in rapporto alla lastra o lapide che funge da supporto o è comunque destinata alla scrittura epigrafica. Nonostante la sua importanza, tale significato non fu messo in rilievo da Susini, né mi risulta che altro studioso vi abbia adeguatamente richiamato l’attenzione. Converrà dunque ora documentare tale valore attraverso alcuni esempi.
In CIL II 391 si legge:… scribi in titulo versiculos volo quinque decenter ǀ Valerius Avitus hoc scripsi … , cioè « … voglio che siano scritti convenientemente sulla lapide cinque versetti, ǀ Valerio Avito scrissi questo … ». È assai chiaro qui l’uso di titulus nel senso di supporto lapidario.
In CIL VIII 1571 (= CLE 966) si dice invece:
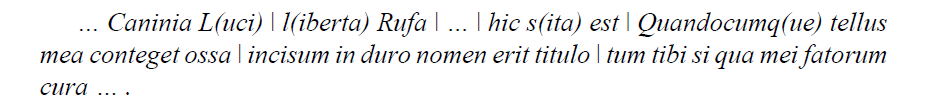
In questo testo si evidenzia la qualità materiale della lastra funeraria. Inoltre, si istituisce una precisa corrispondenza di funzione tra tellus e titulus. La terra custodirà le spoglie della defunta, la lapide, invece, ne conserverà il nome iscritto. Qui titulus ha proprio il valore di lapis, come risulta chiaro anche da un confronto con un’altra iscrizione metrica (CLE 965), dove si legge: Quandocumque levis tellus mea conteget ossa ǀ incisum et duro nomen erit lapide … [38].
Si consideri anche CIL VI 33960 (= CLE 1111), cronologicamente collocabile tra la seconda metà del I secolo d.C. e gli inizi del seguente [39]. Al v. 4 si trovano le seguenti parole:
![]()
Gabriel Sanders ha reso perfettamente il valore di questo testo (in particolare di titulus) traducendo «tu trouveras mon nom gravé sur la pierre»[40]. Sostanzialmente concorde la versione di Anne Kolb e Joachim Fugmann: «Du wirst meine(n) Namen auf meinem Grabstein angebracht finden» [41].
Così pure dovrebbe intendersi la parola in CIL VIII 11549 (CLE 572), una iscrizione della fine del Principato dove tra l’altro si dice:
![]()
Ancora Sanders, che nel corso delle sue ricerche si è fatto sempre più sensibile alle diverse possibilità di interpretazione di titulus [42], rende efficacemente «per sempre i miei compagni hanno fissato sulla pietra il mio nome» [43].
Notevole è infine CIL V 1863, un’iscrizione rupestre commemorativa dell’apertura di una strada in un pericoloso valico di montagna, oggi situato al confine tra Italia e Austria, nelle vicinanze del Passo di Monte Croce Carnico – Plöckenpass. L’iscrizione è datata [44] a non prima della fine del III secolo d.C. Dopo la dedica alle divinità e la dichiarazione di scioglimento del voto si legge:
![]()
Nelle righe successive si elencano le motivazioni dell’impresa. Ai fini del nostro discorso, è interessante rilevare che, nel testo appena citato, l’autore si considera susceptor operis aeterni ed equipara il monte a un immenso titulus, cioè a una gigantesca lapide, sulla quale egli ha voluto fissare, a chiare lettere, la memoria scritta di quanto compiuto. Il monte assolve qui la funzione di una targa monumentale per la scrittura epigrafica. L’enfasi delle parole di Hermias è palmare.
Titulus , comunque, viene usato in alcuni casi anche come denominazione della lapide, che funge semplicemente da mezzo di chiusura della tomba. Così ad esempio in CIL V 2417 (= CLE 1157), dove tra l’altro è detto: Parva sub hoc titulo Festi ǀ sunt ossa, lapillo ǀ quae maerens fato condiǀdit ipse pater , «Qui sotto la lapide sono le piccole ossa di Festio; dolente ǀ con breve pietra lo coprì il padre stesso per fato» [45].
Titulus , dunque, nel senso di semplice lastra o lapide destinata all’iscrizione. Di tale significato del termine latino si è tenuto fin troppo poco conto negli studi moderni, tanto in sede di esegesi di alcuni testi epigrafici quanto, e forse più ancora, per altri di carattere letterario. Molte occorrenze della parola dovrebbero essere riconsiderate alla luce di questa ulteriore possibilità interpretativa. Mi concentrerò qui su un paio di casi soltanto , anche al fine di dare notizia dei primi usi sicuri di titulus nel senso appunto di supporto lapidario. Nel IX libro delle Metamorfosi di Ovidio (vv. 791–794) si leggono i seguenti versi:
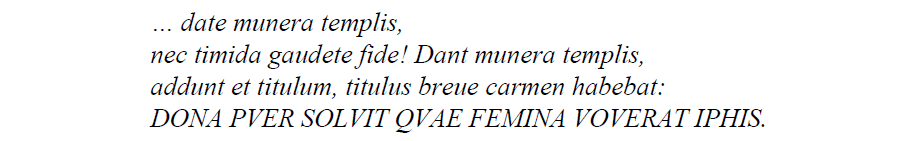
Come si vede, dal v. 792 si descrivono in successione l’offerta dei munera, l’aggiunta di una lapide votiva e il contenuto della iscrizione (metrica), cioè il carmen inciso sulla lapide stessa. Nel carmen sono indicati il nome del donatore e la ragione dello scioglimento del voto. Il passo ovidiano merita speciale attenzione, perché titulus e carmen non sono usati come sinonimi, come si è spesso sostenuto. Piuttosto, essi sono adottati in rapporto a realtà ben distinte: la lastra che funge da supporto e il componimento in versi su quella iscritto. Una traduzione davvero rispettosa dovrebbe tenerne conto. Lodevole da questo punto di vista l’interpretazione di Alan D. Melville:
Meritevole di particolare attenzione è poi un’altra occorrenza della parola ancora in Ovidio. Il poeta , sconsolato per la malattia e l’esilio, sente prossima l’ora della fine. In trist. III, 3, vv. 71–80, si rivolge dunque all’amata moglie e la istruisce sul monumento funerario da allestire per lui. È egli stesso a dettare i pochi versi, che dovranno essere convenientemente incisi sul marmo in sua memoria, e a commentare subito dopo che hoc satis in titulo est (v. 77). La sua speranza in una fama futura riposa, infatti, in monumenti maiora et diuturna magis , i libelli:

In titulo : l’interpretazione di queste parole al v. 77 ha dato filo da torcere a non pochi studiosi. Qualcuno non le traduce neppure («Those lines suffice»[47]). Altri intendono titulus semplicemente nel senso di iscrizione, cioè di testo destinato alla lapide, e d’altra parte non concedono molta attenzione al valore di in + ablativo. Rendono, dunque, genericamente «Tanto basta per la scritta» [48], «C’est assez pour mon épitaphe»[49] o in forme simili. Ma se Ovidio afferma che nel loro insieme quei pochi versi ( hoc) sono sufficienti (satis est) in titulo, è chiaro che titulus e i versi prima dettati non sono la stessa cosa. L’interpretazione corrente va a mio avviso messa da parte.
Titulus , in realtà, è qui usato in riferimento al supporto lapidario, sul quale i versi saranno incisi. In altre parole, il poeta intende riferirsi proprio alla lapide (o, in senso più largo, alla tomba), cui quelle parole sono riservate. L’espressione in titulo del v. 77 non è dunque altro che variatio di in marmore del v. 72. Titulus e marmor sono qui sinonimi, indicano la stessa realtà: la lapide destinata all’iscrizione funeraria, come aveva già ben compreso I. N. Herescu[50].
Del resto, solo così si capisce il discorso sviluppato dal poeta ai versi successivi (fino al v. 80). Qui egli istituisce un confronto tra due diverse modalità di salvaguardia della propria memoria, due ben distinti generi di monumenta: il titulus da un lato, i libelli dall’altro. Non a caso l’uno e gli altri sono menzionati nello stesso, cruciale, v. 77. Il primo, dice Ovidio, sarà iscritto al momento necessario, ma con poche parole. Gli altri sono invece già ricchi della sua scrittura di poeta e sono quindi più importanti. Saranno dunque i libelli ad assicurare al loro autore la meritata memoria. Come si vede, il riconoscimento dell’esatto valore del termine titulus permette non solo di intendere il v. 77 in maniera corretta, ma anche di comprendere il discorso espresso dal poeta in tutta questa parte del componimento.
Se nella documentazione sinora esaminata titulus è riferito alla superficie epigrafica e, in senso lato, al supporto lapidario destinato, ma non ancora corredato, dalla scrittura, lo stesso termine ricorre in altri casi in senso opposto, al fine di indicare il testo epigrafico, indipendentemente dal supporto che lo accoglie. La parola è dunque usata nel senso puro e semplice di scrittura esposta [51]. Sono così indicate scritte di vario genere: «dipinte, graffite, incise», diverse per contenuto, «essendo ora pubblicitarie, ora politiche, ora funerarie, ora celebrative, ora pubbliche, ora privatissime, di appunto o di insulto o di scherzoso ricordo», ma soprattutto «esposte dovunque, con qualche preferenza, è vero, per alcuni luoghi deputati, piazze, fori, edifici pubblici, necropoli, ma soltanto per le più solenni; non per le altre, indifferentemente sparse ovunque vi fosse l’ingresso di una bottega, un quadrivio, un pezzo di intonaco libero ad altezza d’uomo» [52].
Tale significato della parola, a differenza di quello già visto di lapide o superficie da iscrivere, è assai ben conosciuto. Perciò basterà ora illustrarlo con pochi esempi. Va detto anzitutto che in questo sensotitulus compare numerose volte già in Tito Livio, per esempio in Ab urbe condita XL, 52, 5–10. Qui lo storico informa sulla dedicazione, avvenuta nel 179 a.C. al Campo Marzio, di un tempio ai Lari Marini: supra valvas templi tabula cum titulo hoc fixa est: “Duello magno dirimendo … ” , «sopra le porte del tempio, fu affissa una tavola con questa iscrizione: “Per mettere fine a un grande conflitto … ”» . La distinzione tra supporto, la tabula, e testo iscritto, il titulus, è netta e non ha bisogno di particolare commento.
Anche Ovidio non rinuncia a servirsi ripetutamente della parola in questo senso. Così nel secondo componimento delle epist., vv. 65–68. 73–74, si legge che Fillide, sedotta e abbandonata dal giovane Demofoonte, sconsolata dichiara:
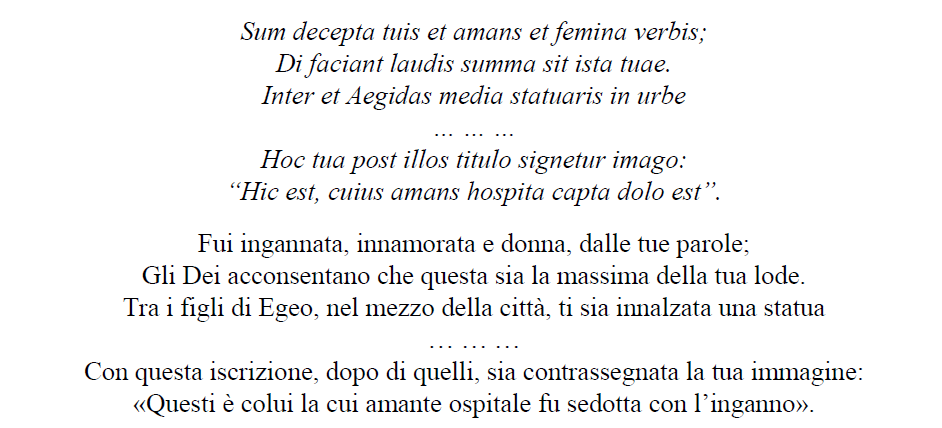
La distinzione al v. 74 tra i versi da iscrivere, chiamati nel loro insieme titulus, e l’imago cui sono destinati, è evidente. Altrettanto potrebbe dirsi circa la fine del XIV componimento delle epist., dove Ipermestra, l’unica figlia di Danao rimasta fedele al marito e perciò condannata alle catene, scrive al suo uomo, unico sopravvissuto di tanti fratelli, e in un ultimo disperato appello lo supplica o di aiutarla, oppure di ucciderla e di incidere, dopo la sepoltura, un breve componimento in versi sulla tomba (vv. 127–130):

Verso la metà del I secolo d.C. anche Petronio utilizza, almeno in qualche occasione, la parola in questa accezione. Così per esempio al cap. 34, 6–7, dove Trimalcione riflette, a modo suo naturalmente, sulla brevità della vita umana, dopo avere ascoltato uno dei commensali leggere ad alta volte le etichette delle bottiglie di vino:
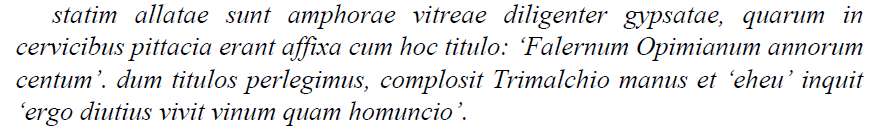
Titulus compare due volte, prima al singolare, poi al plurale. Almeno l’interpretazione della prima occorrenza è sicura. Pittacia sono le etichette delle anfore di vetro, titulus l’iscrizione sulle stesse, dove si informava, anzi si certificava l’annata e la provenienza del vino. Varie amphorae vitreae contenevano vino proveniente da area campana lasciato invecchiare cento anni! Così recitava l’iscrizione, il titulus.
Incerta invece l’interpretazione della seconda occorrenza. Il passaggio alla forma plurale (dum titulos perlegimus) potrebbe essere dovuto alla volontà di usare la stessa parola con un valore più comprensivo, nel senso di etichette (iscritte). Così almeno secondo alcuni studiosi. Tuttavia, l’uso immediatamente precedente di titulus col significato di iscrizione, sebbene al singolare, vale secondo altri come argomento contrario. Anche io non escluderei affatto che Petronio in entrambe le occasioni abbia semplicemente voluto richiamare l’attenzione su ciò che era scritto sulle diverse etichette: al banchetto di Trimalcione ci si divertiva insomma a leggere la scritta informativa sull’annata di questa o quella bottiglia di vino. È in ogni caso assodato il senso della parola all’inizio del brano. Sull’uso di titulus e in generale sulle iscrizioni menzionate da Petronio cf. J. Nelis-Clément, D. Nelis, Petronius’ epigraphic habit, Dictynna 2 (2005) 2–14; J. R. W. Prag, Cave navem, CQ 56/2 (2006) 538–547.
Se volessimo indagare ulteriormente l’uso di titulus nel senso di iscrizione in documentazione coeva o più tarda, ci troveremmo senz’altro di fronte a numerose attestazioni da considerare. Mi limito a presentare un paio di casi. In CIL VIII 9513 la defunta si rivolge ai figli con tali parole:
![]()
Notevole qui la combinazione delle parole titulum monumenti, riferite all’iscrizione sulla tomba, col verbo recito, sul cui significato rimando in generale al dotto articolo di U. E. Paoli, ‘Legere’ e ‘recitare’, A&R, n. s. 3 (1922), 205–207, e a E. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, IV, Patavii 1940, s. v. recito, 28.
Interessante anche CIL XII 5276 (= CLE 2119), che si conclude con le parolene terra aliena ignoti cum nomine obissent ǀ hic titulus parvo proloquitur lapide. Helmut Häusle traduce correttamente: «Auf daß sie nicht auf fremder Erde unbekannt zusammen mit ihrem Namen untergegangen seien, spricht hier von ihnen die Inschrift auf dem kleinem Stein»[53].
Analizziamo ora un ultimo prodotto epigrafico, per mostrare la vitalità di questa accezione del termine latino per tutta la tarda antichità e sino alle soglie del Medioevo. Si tratta di CLE 917, un’iscrizione commemorativa fatta incidere su una lapide tra il 538 e 545 da papa Vigilio (537–555) a seguito del restauro del santuario di sant’Alessandro, devastato poco prima dai Goti di Vitige:
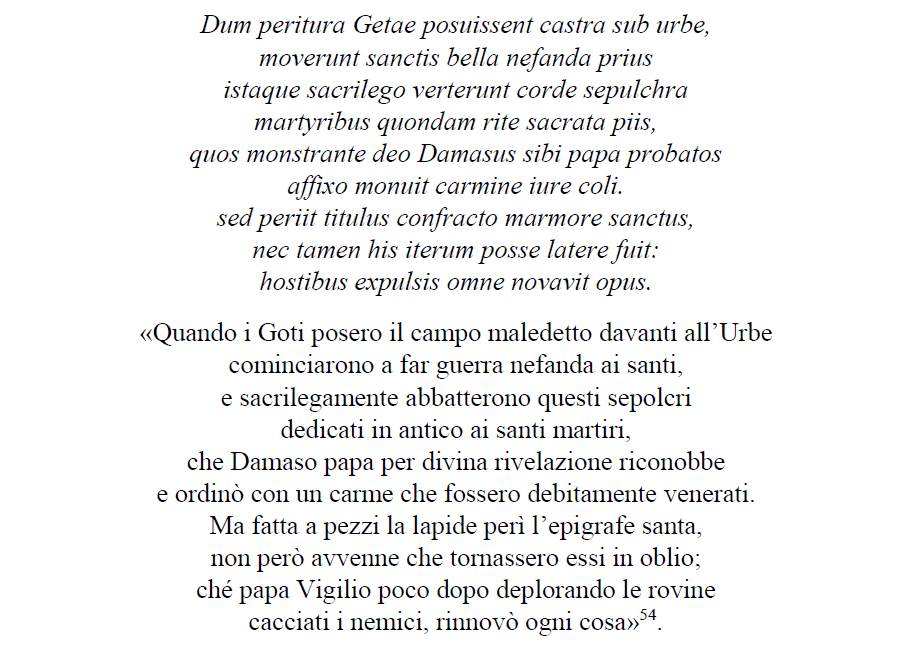 [54].
[54].
Qui titulus è usato proprio nel senso di carmen affixum e dunque con un significato ben diverso da quello di marmor. Titulus, insomma, è adottato in questo caso in un’ accezione opposta a quella di cui si era servito Ovidio, molti secoli prima, in trist. III, 3, 77.
Nelle due iscrizioni di Filippi e in altra documentazione censita, titulus indica la superficie idonea o la targa, la lastra (la lapide) destinata all’iscrizione. In altre occasioni, come pure si è visto, il termine è usato in riferimento al solo testo epigrafico, del tutto a prescindere dal supporto che lo accoglie. Tra questi due possibili estremi si collocano tutti quei casi, e non sono pochi, in cui titulus è utilizzato come denominazione del prodotto epigrafico nel suo complesso[55], cioè per indicare la superficie e più in generale la targa, il cartello, la lapide, la stele, insomma il monumento già segnato dalla scrittura.
Partiamo da un esame di CIL VI 24799, di cui purtroppo non mi sono note riproduzioni fotografiche:

Come si vede, nelle ultime righe si enuncia una sanzione contro qualsivoglia violazione del monumento funerario e contro la manomissione e/o alterazione del titulus. Si prendono così le misure contro qualsiasi forma di oltraggio della tomba da parte di mano ostile. Ma in che senso è usato qui titulus? E cosa significano esattamente le parole quisquis hoc monumentum violaverit aut titulum deasciaverit aliove quo nomine inscripserit, dabit … ?
«Wenn jemand dieses Grabmonument schändet oder die Inschrift ausmeißelt und einen anderen Namen hinsetzt, zahlt er ... ». Così esse sono state intese qualche anno fa[56]. Tale versione del testo latino non sembra tuttavia pienamente soddisfacente, soprattutto perché non rende in modo adeguato la sintassi latina in un punto importante. «Aliove quo nomine» non può essere reso come se si trattasse di un complemento in accusativo di inscripserit. Infatti, l’accusativo di inscripserit — c’è appena bisogno di rilevarlo — è lo stesso di deasciaverit: titulum.
Per intendere correttamente questo testo, occorre dunque ripartire da deasciare e tenere conto di quanto la critica ha osservato sul suo significato. Esso appartiene a un gruppo di verbi esprimenti l’azione di deteriorare, degradare, consumare, insomma alterare la superficie di un monumento (un’ara, un sepolcro, in teoria anche una semplice lapide) e in special modo le sue parti caratteristiche, anzitutto quella contenente l’iscrizione e naturalmente quella che accoglie l’apparato figurativo.
A riguardo cf. la sintesi di S. Panciera, Deasciare , exacisclare, exasciare a Salona e ad Aquileia, Latomus 19 (1960) 701–707, e il contributo di P.-M. Duval, L’«ascia». 2. Dossier «ascia», extraits, in: Travaux sur la Gaule (1946–1986) (Publications de l’École française de Rome 116), Rome 1989, 495–502: dopo avere vagliato alcune iscrizioni, tra cui CIL VI 24799, lo studioso osserva che «exacisclare (et, par extension, exasciare, deasciare) désigne le fait de dégrader une partie essentielle de la tombe, celle qui comprend l’emplacement de l’épitaphe».
Il significato di deasciare è di orientamento per l’interpretazione di CIL VI 24799 nel punto che ci interessa. Se infatti l’iscrizione occupava una parte della superficie del monumento funerario, attraverso titulus si sarà voluto indicare proprio lo specchio di scrittura da non eradere, per quel che esso già conteneva, né da iscrivere col nome di qualcun altro. D’altra parte, è chiaro che se il testo sopra citato compariva in una lapide ben distinta e separata dalla tomba vera e propria, allora qui titulus sarà stato usato piuttosto in riferimento all’intera targa iscritta, che non andava deteriorata né segnata con qualche altro nome [57].
Non essendo a me noto il contesto monumentale di appartenenza dell’iscrizione, non mi è ovviamente possibile scegliere con assoluta sicurezza tra l’una e l’altra possibilità interpretativa. Se tuttavia un giorno si dimostrasse valida la prima, ne conseguirebbe che anche in CIL VI 24799 titulus è adottato come denominazione dello specchio epigrafico, ma con una differenza di non poco conto rispetto alle iscrizioni di Filippi sopra esaminate. In queste ultime titulus indica la superficie preparata, ma non ancora occupata dall’iscrizione. Nel caso di CIL VI 24799 si tratterebbe della superficie già iscritta.
Già nella più antica documentazione a nostra disposizione titulus risulta comunque adottato in rapporto a targhe e insegne iscritte per scopi differenti. Per esempio, la parola è usata per quei cartelli che si esponevano a Roma in occasione del trionfo dei condottieri vittoriosi. Si trattava di veri e propri manifesti propagandistici, sui quali era indicato il nome delle città conquistate o dei personaggi ridotti in schiavitù o ancora il bottino strappato al nemico. Già Properzio si serve in tal modo della parola a proposito di un trionfo di Cesare Augusto (Prop., III, 4, 11–16):
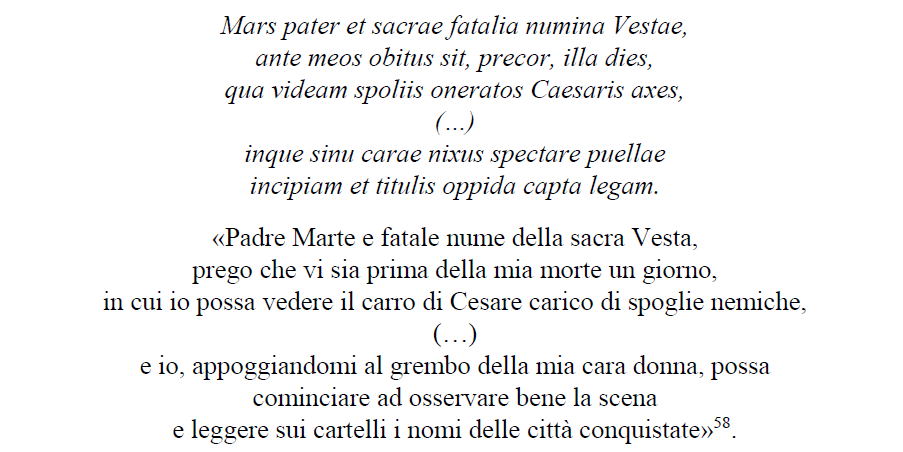 [58].
[58].
Anche Svetonio si serve di titulus nella stessa accezione, informando sul trionfo di Giulio Cesare nel 46 a.C. Dopo avere rapidamente sconfitto Farnace II del Ponto, Cesare celebrò il suo ingresso a Roma con lungimirante calcolo politico: lasciò esporre uno cartello ( praetulit titulum) a carattere propagandistico, contenente tre parole: VENI·VIDI·VICI [59].
Tutto particolare fu un trionfo celebrato circa un secolo dopo da Nerone. Esibitosi ai giochi in Grecia, l’imperatore si autoproclamò ovviamente vincitore. Tornato in Italia, al suo ingresso a Roma, sfilarono in primo luogo le corone “conquistate” e così una serie di tituli, cioè vere e proprie insegne o cartigli, sui quali era indicato dove, come, quando e contro chi l’imperatore era risultato, si fa per dire, vincitore: praeeunte pompa ceterarum [coronarum] cum titulis, ubi et quos quo cantionum quove fabularum argumento vicisset , così racconta Svetonio, Nero 25, 1 [60].
Nella Roma imperiale si faceva uso quotidiano di cartelli iscritti di ogni genere e non solo per interessi politici, ma anche con finalità (almeno in apparenza) religiosa. Ancora Svetonio racconta (Aug. 59) che nonnulli patrum familiarum testamento caverunt ut ab heredibus suis praelato titulo victimae in Capitolium ducentur votumque pro se solveretur, quod superstitem Augustum reliquissent . Lo storico intende cioè dire che non pochi capi famiglia disposero, per testamento, che i loro eredi conducessero vittime al Campidoglio, facendosi precedere da un cartello indicante che così si scioglieva il loro voto di morire lasciando Augusto ancora in vita [61].
Naturalmente v’erano anche cartelli a carattere commerciale o per qualsiasi altro genere di informazione al pubblico. Nel Satyricon di Petronio si legge (7, 3) che il giovane Encolpio, ingannato da una perfida vecchia, si ritrova suo malgrado in un lupanare: Cum ego negarem me agnoscere domum, video quosdam inter titulos nudasque meretrices furtim spatiantes , «mentre io asserivo di non conoscere quella casa, vedo certuni che si aggiravano loscamente tra cartelli e discinte prostitute». Titulus è qui applicato a quel genere di insegne esposte all’ingresso dei locali delle meretrici. Su tali cartelli si indicava il nome della prostituta o il prezzo della prestazione o entrambe le cose [62].
Attraverso tabelle iscritte si notificava pure al pubblico il nome di un condannato a morte e la motivazione della pena. Su questo genere di tituli abbiamo notizie ancora una volta da Svetonio e da altre fonti[63].
Questo punto richiama alla memoria fonti notissime sulla crocifissione di Gesù di Nazaret, in particolare il vangelo secondo Giovanni, cap. 19, 19–20: ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον, Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. Sulla croce Pilato fece dunque apporre un τίτλον, su cui era iscritto in più lingue il motivo della condanna del Nazareno. Il testo citato è importante per almeno due ragioni. La prima è che qui per la prima volta, a mia conoscenza, compare il latinismo τίτλος. La seconda è di natura semantica. Talvolta si liquida la questione del significato della parola nel brano giovanneo parlando semplicemente di ‘scritta’ sulla croce. Occore invece più precisamente dire che nel passo del vangelo τίτλος è usato proprio come denominazione del cartello iscritto: le parole ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον vanno dunque intese nel senso che Pilato «scrisse (= fece scrivere) una insegna» contenente la motivazione della condanna del Nazareno e la fece fissare sulla croce [64].
Ma titulus fu pure usato per indicare altre realtà iscritte, come una lapide funeraria, una stele, un’ara, un sepolcro [65]. Tale impiego si costata di frequente nella documentazione epigrafica pervenuta. Un paio di esempi. CIL XIII 2104 (= CLE 1278) si apre con queste parole:
![]()
Qui titulus non è riferito alla sola iscrizione funeraria, come pure si è affermato[66], ma all’oggetto iscritto nel suo complesso: si trattava di una stele, come sappiamo[67], fatta collocare dal committente ad umbras. La parola, retta dainstituit, è usata sostanzialmente nel senso di monimentum. Conferma questa conclusione un confronto con CIL V 7956, dove si legge … ut nomen eius aeterna lectione celebraretur hoc monimentum instituit .
Notevole anche CIL X 2487, dove si legge:
![]()
In questo caso si pronuncia una minaccia e al tempo stesso una maledizione non tanto contro la pura e semplice rimozione dell’iscrizione, ma, più in generale, contro l’asportazione della lapide intera (!), vista nel suo complesso: quale monumento iscritto. Una buona traduzione del testo citato dovrebbe esprimere questo concetto in forma adeguata. La recente interpretazione di Christiane Kunst appare da questo punto di vista soddisfacente: «Möge den, der diesen Grabstein von der Stelle rückt, der Zorn der Schatten derer treffen, die hier begraben liegen» [68].
In quella lotta titanica degli antichi per l’eternità — meglio: per la sopravvivenza della loro memoria individuale — è il monumento iscritto nel suo complesso a giocare un ruolo centrale. Ed è proprio in questo senso che titulus appare sovente utilizzato nella documentazione epigrafica a nostra disposizione, soprattutto in quella di uso funerario, dove si leggono espressioni come titulum fecit, titulum posuit o titulum posuerunt. Negli studi moderni questo genere di espressioni sono spesso rese, alquanto meccanicamente, e con qualche ambiguità, con «fece l’iscrizione», «pose l’iscrizione» o «posero l’iscrizione». Alla luce di quanto prima osservato, è invece consigliabile, laddove possibile, orientarsi per una traduzione più precisa ed esplicita. Attraverso formule di questo genere si volle in realtà indicare, almeno in molti casi[69], la committenza e produzione dell’intero monumento iscritto, cioè chi «fece la lapide» o «la stele»; o, ancora, chi la «fece deporre» o «collocare» sulla tomba del defunto.
In riferimento ad aspetti o realtà epigrafiche, titulus fu dunque in uso nel mondo romano per indicare ora la superficie o la lastra destinata all’iscrizione, ora l’iscrizione stessa, ora il monumento epigrafico nel suo complesso. È dal contesto (nel senso più ampio) che siamo chiamati, ogni volta, a stabilire in quale di questi valori il termine fu utilizzato da un dato autore o in una determinata iscrizione. Ma è sempre possibile una scelta sicura tra i significati sin qui visti? A questo proposito giova riflettere ancora una volta sulle due iscrizioni del culto di Silvano. Nel loro insieme esse costituiscono un caso fortunato. Di entrambe è ben noto l’ambito monumentale d’appartenenza e d’altra parte è pure conservato, per intero, il passo in cui titulus viene utilizzato. Le condizioni per assodare il significato della parola sono ideali. Di tanti altri testi epigrafici, dove pure è attestato titulus, è invece ignoto il contesto originario (e tutto quello che ne deriva per la cronologia e altro ancora), oppure l’iscrizione è corrotta proprio nelle parti salienti per la comprensione del suo contenuto. In casi del genere vengono progressivamente a mancare i requisiti necessari all’accertamento dell’esatto significato del termine latino.
Non sempre, dunque, è possibile prendere posizione sicura sull’esatto valore della parola. Ciò vale naturalmente non solo in sede di esame di prodotti epigrafici, ma anche quando si analizza questo o quel passo di uno scrittore latino (uno storico, un poeta o altro, non fa differenza), che utilizza titulus in rapporto a una data realtà, senza però aggiungere particolari indicazioni, in quanto conta sul fatto che il pubblico, che gli è contemporaneo, colga senza difficoltà il suo riferimento. Se non siamo altrettanto bene informati come il pubblico di allora sul contesto della notizia, l’esatto significato della parola rischia di rimanere incerto. In casi del genere, non rimane quindi che vagliare con massima attenzione i sia pur esigui dati a disposizione, nella speranza di riuscire comunque a ricavare qualche informazione utile, se non altro, per approssimarci all’esatta interpretazione del termine latino. È proprio così che Géza Alföldy è riuscito, in un magistrale lavoro, a mettere in piena luce l’esatto significato del plurale tituli in una notizia di Velleio Patercolo (II, 39, 2) sul Foro di Augusto, superando una serie di ipotesi che si trascinavano sin dai tempi di Theodor Mommsen, senza che l’una si affermasse in modo convincente sulle altre.
Nel passo di Velleio la parola non è infatti riferita alle parti di una singola iscrizione onoraria, concernente un gruppo di statue bronzee — una quadriga — al centro del Foro di Augusto, come si era tra l’altro a lungo pensato. Velleio intende in realtà indicare singoli monumenti epigrafici lì collocati e dedicati all’Imperatore dai popoli, o meglio, dalle province da lui istituite[70].
È chiaro, d’altra parte, che la completa mancanza di conoscenza del contesto finisce per costituire un impedimento talvolta insormontabile per la scelta tra i possibili significati. Il problema è più grave di quanto si pensi. Basti un ultimo esempio, al fine di mostrare problemi e insidie della documentazione e allo stesso tempo importanza ma anche limiti dei nostri tentativi di esegesi.
CIL I2 2123, oltre a costituire un rilevante testo dell’epigrafia giuridica romana di età tardorepubblicana, contiene una delle prime occorrenze di titulus, forse in assoluto la più antica. Il contenuto dell’epigrafe è ben noto e sopra lo abbiamo brevemente ricordato. Si tratta della cessione di un terreno, in località sarsinate, per la sepoltura di poveri non immeritevoli [71]. Il detto terreno era situato inter pontem Sapis et tituǀlum superiorem qui est in ǀ fine fundi Fangoniani . La prima indicazione non pone ovviamente problemi esegetici. Li pone invece la seconda e sono difficilmente superabili. In cosa propriamente consisteva il titulus superior? Era una targa con una qualche iscrizione in un punto più elevato del fondo? Un qualche cippo terminale? O cos’altro?
L’estensore del testo lo sapeva bene. Altrettanto bene dovevano saperlo i suoi conterranei e coloro che avessero frequentato il terreno a quell’epoca. Ma non noi, perché oggi quelle parole non sono più esposte nel loro originario contesto, andato irrimediabilmente distrutto, e il testo dell’iscrizione non fornisce elementi utili per ricavare in altra maniera l’esatto significato del riferimento. C’è da meravigliarsi che i tanti studiosi del documento epigrafico non abbiano potuto fare altro che citare in latino quell’indicazione, rinunciando a una traduzione? Anche coloro che hanno speso più energie per l’esegesi di titulus superior, hanno optato, in fin dei conti, per la cautela. Susini, un pioniere nell’indagine dei significati di titulus, si è tormentato a lungo su questa iscrizione proprio alla ricerca dell’esatto valore della parola. «Quel cartello lassù», così la intende. Ma lo studioso è il primo a non farsi illusioni su tale conclusione [72].
Abbiamo qui considerato una occorrenza, di cui non siamo realmente in grado di stabilire l’esatto significato, perché non conosciamo nel modo dovuto il contesto monumentale di appartenenza dell’iscrizione. Vi sono comunque molti altri casi sui quali siamo assai meglio informati o almeno abbiamo qualche margine di movimento ai fini dell’ interpretazione, se non altro perché il contesto verbale di titulus, cioè il testo stesso in cui è adottata la parola, fornisce qualche elemento di riflessione. È soprattutto in tali circostanze che ci si deve guardare dal ridurre in modo sommario il termine latino a sinonimo o equivalente di inscriptio o a intenderlo semplicemente nel senso di iscrizione, in quanto questo non fu che uno dei possibili significati, ma certamente non l’unico, neppure in relazione a realtà epigrafiche, come si spera di avere potuto mostrare in questo lavoro [73].
- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Universität Basel,
Theologische Fakultät, |
Emanuele Castelli |
* Desidero ringraziare la Alexander von Humboldt Stiftung, che mi ha conferito una Research Fellowship biennale (ottobre 2012–settembre 2014), per indagare, al Wissenschaftlich-theologisches Seminar della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, la genesi e la storia del titolo letterario nella civiltà greco-romana come pure gli usi e i significati della parola titulus nel mondo romano. L’essenziale del presente lavoro è stato concepito nel corso di tali ricerche. Desidero, inoltre, ringraziare: Winrich Löhr (Heidelberg), academic advisor del progetto, per tutti gli stimoli e i consigli che mi ha trasmesso in questi anni; Carlo Carletti (Roma – Bari) e Tiziano Dorandi (Paris) per il continuo e proficuo scambio di pensieri sull’argomento trattato in queste pagine; Sergey Kim (Basel) e Andrea Mele (Basel) per il dialogo intenso su questo e altri problemi di carattere filologico.
[1] Così F. A. Wolf, Prolegomena ad Homerum, Halis Saxonum 1795, XLV.
[2] Per una prima informazione cf. B.-J. Schröder, Titel und Text. Zur Entwicklung lateinischer Gedichtüberschriften. Mit Untersuchungen zu lateinischen Buchtiteln, Inhaltsverzeichnissen und anderen Gliederungsmitteln (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 54), Berlin, New York 1999, 319–328; C. Moussy, Les appelations latines des titres de livres, in: J.-C. Fredouille, M.-O. Goulet-Cazé, P. Hoffmann, P. Petitmengin (ed.), avec la collab. de S. Deléani, Titres et articulations du texte dans les œuvres antiques, Actes du colloque international de Chantilly, 13‑15 décembre 1994 (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité 152), Paris, Turnhout 1997, in particolare 6–7.
[3] Cf. H. Heumann, E. Seckel,Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, s. v. titulus, Graz 111971, 586–587. Punto di riferimento rimane comunque A. d’Ors, Titulus, AHDE 23 (1953) 495–513; un tentativo di aggiornamento è compiuto da R. Haase, Untersuchungen zur Verwaltung des spätrömischen Reiches unter Kaiser Justinian (527 bis 565) , Wiesbaden 1994, 63–68, 89, 103. Importante sotto vari aspetti è ora M. U. Sperandio,Il ‘codex’ e la divisione per ‘tituli’, in: Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, Napoli 2007, 435–472.
[4] Generalmente ci si accontenta col dire che titulus servì nel mondo romano per designare anche proprietà di carattere immobiliare e che a partire dal IV secolo il termine si specializzò in ambienti cristiani in riferimento a determinati luoghi di culto e beni della comunità di Roma (e non solo di questa). In questo senso cf. P. Kirsch, Die römischen Titelkirchen im Altertum, Paderborn 1918, in particolare 1–3; L. Völkl, Die konstantinischen Kirchenbauten nach den literarischen Quellen des Okzidents , RACr 30 (1954) 110–111; P. Testini,Archeologia cristiana. Nozioni generali dalle origini alla fine del sec. VI, Bari 21980, 603–607.
[5] Cf. G. Susini, Il lapicida romano, Bologna 1966, 18–21. Va qui rilevata la mancanza di una valida discussione dei significati della parola in opere di carattere generale o in introduzioni alla disciplina epigrafica pubblicate dalla fine del XIX secolo a oggi. La lacuna è già nella monumentale opera di E. Hübner, Exempla scripturae epigraphicae Latinae, Berlin 1885. Hübner, salvo qualche accenno, si interessa poi soprattutto di «testimonia veterum» concernenti «scalpendi» o «sculpendi vocabula»: cf. pp. XXII, XXV–XXVI e soprattutto XXIX–XXX. Per altre informazioni sugli studi del XX secolo, cf. infra.
[6] Si pensi all’Epigraphische Datenbank Clauss-Slaby, all’Epigraphische Datenbank Heidelberg o ancora all’ Epigraphic Database Roma.
[7] Si tratta di CIL I2. Pars posterior. Fasciculus quintus. Indices fasciculorum I–IV, post Ernestum Lommatzsch curavit Ioannes Krummrey , Berlin, Boston 2015.
[8] Così ricorda Gell. 10, 11. Tale notizia, sempre che il testo tramandato non sia corrotto proprio in questo punto, è d’incerta valutazione per più di una ragione.
[9] La stessa etimologia di titulus è discussa. J. André, Les mots à redoublement en latin, Paris 1978, 79, suppone che la parola sia esito di un raddoppiamento parziale della radice *tel-, con cui si esprimeva l’idea di «plate» o «surface plate». In origine titulus, la cui forma iniziale sarebbe dunque stata *te-tel- o *ti-tel-, avrebbe indicato la superficie o il supporto dell’iscrizione piuttosto che l’iscrizione stessa. Per altre ipotesi: A. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 3., neubearb. Aufl. von J. B. Hofmann, Heidelberg 1954, 720–721. Uno studio dell’etimologia di titulus dovrebbe tenere conto anche dell’esistenza di varianti come tetelus o titelus, come in CIL VI 8987 (titelo moles[tet]) e altrove. Per una prima informazione a riguardo cf. C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo. Ideologia e prassi , Bari 2008, 137–138, 243–244, 298–299.
[10] Testo, traduzione e commento in M. Massaro, Epigrafia metrica latina di età repubblicana, Bari 1992, 115–195.
[11] Così traduce Massaro, Epigrafia metrica (supra, n. 10) 116: «Ehi, tu che volgi lo sguardo svagato a queste dimore di morte, trattieni il passo e leggi attento la nostra iscrizione, che l’affetto del padre dedicò a sua figlia, là dove si sarebbero riposti i resti del suo corpo», mentre E. Courtney, Musa lapidaria . A selection of Latin verse inscriptions, Atlanta 1995, 47: «Ho there, you who with random eye survey the homes of the death, stay your step and read my epitaph, which the love of my father gave to his daughter so that the remains of my body might bestow themselves there».
[12] Sull’uso di titulus nel senso di cartello iscritto o lapide destinata alla lettura cf. infra.
[13] Su ciò cf. Massaro, Epigrafia metrica (supra, n. 10) 118–122. Per un aggiornamento cf. W. Suerbaum (ed.), Die archaische Literatur. Von den Anfängen bis Sullas Tod. Die vorliterarische Periode und die Zeit von 240 bis 78 v. Chr. (Handbuch der lateinischen Literatur der Antike I), München 2002, 336.
[14] Scrivo qui Balbus, ammesso che l’integrazione proposta dai moderni sia giusta. Per un’analisi dell’epigrafe cf. G. Susini, Fundus Fangonianus, StudRomagn 20 (1969) 333–339, ripubblicato in G. Susini, Sarsina. Studi di anitichità, S. Giovanni in Persiceto 1982, 263–69.
[15] Sull’iscrizione tornerò a riflettere alla fine del presente lavoro.
[16] L’iscrizione fu edita nella sezione Inscriptiones latinae liberae rei publicae del volume Epigrafia. Actes du colloque international d’épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance, Rome, 27–28 mai 1988 , Rome 1991, 262–263, nº 24. Per la sua datazione a inizio dell’età imperiale cf. H. Solin, Analecta epigraphica CXL–CXLIV, Arctos 25 (1991) 146–150.
[17] Cf. J. Mallon, Paléographie romaine, Madrid 1952, 57–58, e J. Mallon, Paléographie des papyrus d’Egypte et des inscriptions du monde romain , MH 10 (1953) 141–160, in particolare 146–147.
[18] Per la datazione al I secolo a.C. cf. G. Alföldy, Recensione di M. T. Manni Piraino, Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo (1973), Gnomon 48 (1976) 510–512; P. Kruschwitz, Die sprachlichen Anomalien der Werbeinschrift CIL X 7296, ZPE 130 (2000) 239–240, propende invece per il I secolo d.C.
[19] Così Mallon, Paléographie des papyrus d’Egypte ( supra, n. 17) 146.
[20] Così il testo latino è reso da I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigrafico lapideo , Roma 1987, 126, che segue fedelmente il Mallon.
[21] Cf. Mallon, Paléographie romaine (supra, n. 17) 57–58.
[22] In altri termini, tramite l’insegna si segnalava la capacità della bottega di realizzare stele e colonne di varie forme e dimensioni, secondo le finalità di carattere pubblico e sacro richieste dagli utenti, e di provvedere alla loro iscrizione. Questo l’ovvio significato del testo.
[23] Mi servo per semplice comodo della distinzione, scolastica, tra prodotti epigrafici da un lato e letterari dall’altro, ben sapendo che anche testi iscritti, cioè epigrafici, possono avere valore letterario. La distinzione, in effetti, ha una sua ragion d’essere più per altre ragioni, in particolare per le modalità di produzione, fruizione e conservazione dei testi stessi.
[24] Cf. la bibliografia indicata sopra alla n. 2.
[25] Cf. Cic., Pis. 19.
[26] Cf. Cic., Tusc. V, 10, 30.
[27] Cf. Hor., Carm. IV, 14, 4, 8; Sat. I 6, 17, 2; II, 3, 212, 4: cf. E. Staedler, Thesaurus Horatianus, Berlin 1962, 152. Per l’esegesi del primo passo cf. W. J. Finney, Language and hymnal form in Horace, “Odes” 4.14, Vergilius 31 (1985) 46–47.
[28] Cf. Prop., III, 5, 16; IV, 5, 51; IV, 11, 32.38. Per il reperimento di queste occorrenze mi sono tra l’altro giovato di B. Schmeisser, A Concordance to the Elegies of Propertius, Hildesheim 1972, 851. Per la loro interpretazione cf. G. Giardina (edizione critica e traduzione a cura di), Properzio. Elegie, Roma 2005. In parte diversamente da quanto qui suggerisco, lo studioso intende titulus in IV, 11, 32 nell’accezione di titolo d’onore.
[29] Cf. Tib., II, 4, 54.
[30] I passi sono raccolti da D. W. Packard, A Concordance to Livy, IV, Cambridge, MA 1968, 964.
[31] Tutto il materiale è riunito da R. J. Deferrari, M. I. Barry, M. R. P. McGuire, A Concordance of Ovid, Washington 1939, 1987–1988: dalla lista offerta va però espunto il verso di trist. III, 3, 72: gli autori della concordanza si fondano su una erronea lezione.
[32] È sufficiente consultare l’ Epigraphische Datenbank Heidelberg per un primo quadro dei dati disponibili.
[33] Sull’argomento gli studiosi hanno del resto assunto posizioni diverse. Uno sguardo ai manuali o alle più o meno recenti introduzioni alla scienza epigrafica è da questo punto di vista istruttivo. Alcuni studiosi, pur interessati alla esatta definizione del lessico epigrafico dei Romani, preferiscono non pronunciarsi sul significato di titulus o richiamano ancora alla memoria la definizione, sommaria e per vari aspetti inesatta, fornita da E. Hübner, Römische Epigraphik , in: I. Müller, Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft, I, Nördlingen 1886, 475. Altri si accontentano di dire che titulus indicava il testo scritto, l’iscrizione appunto. Altri ancora ammettono una duplice possibilità di comprensione della parola: titulus — essi osservano — era utilizzato in taluni casi in senso stretto, in riferimento alla scrittura epigrafica, in altri in senso più ampio, per designare l’intero prodotto iscritto . In quest’ottica A. Gordon, Illustrated Introduction to Latin Epigraphy, Berkeley, Los Angeles, London 1983, 144 e 147; e già E. R. Cagnat nella succosa voce titulus curata per il DS , V, Paris 1892, 347, col. 2; cf. anche I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, con un’appendice bibliografica di A. Degrassi, Milano 41991, 1–2.
[34] Su questo concetto cf. infra, n. 51.
[35] Il volume, tradotto in inglese nel 1973, è stato riedito in G. Susini, Epigraphica dilapidata, Faenza 1997, 7–69.
[36] Cf. P. Collart, Philippes. Ville de Macédoine depuis ses origines jusqu’à la fin de l’époque romaine , Paris 1937, 405. Una nuova riflessione sulla datazione di queste due importanti iscrizioni sarebbe auspicabile. Il Collart ne diede anche una riproduzione fotografica: cf. Pl. LXV. Sulle due epigrafi si veda ora P. Pilhofer, Philippi 2. Katalog der Inschriften von Philippi, Tübingen 2000, 170–175, 176–179, 197–205, 205–210.
[37] Cf. Susini, Il lapicida (supra, n. 5) 21.
[38] Sulla datazione di quest’ultima iscrizione agli inizi del I secolo d.C. e per il suo confronto con la precedente cf. F. Bücheler, Carmina Latina Epigraphica, II, Lipsiae 1897, 444–445. La qualità del supporto epigrafico è rilevata anche in altre iscrizioni: cf. E. Gebhardt-Jaekel,MORS OMNIBUS INSTAT – Der Tod steht allen bevor. Die Vorstellungen von Tod, Jenseits und Vergänglichkeit in lateinischen paganen Grabinschriften des Westens , Inauguraldissertation, Frankfurt am Main 2007, 236, n. 314.
[39] Cf. A. Kolb, J. Fugmann, Tod in Rom. Grabinschriften als Spiegel römischen Lebens, Mainz 2008, 211.
[40] Così G. Sanders,Sauver le nom de l’oubli. Le témoignage des CLE d’Afrique et aliunde, in: A. Mastino (ed.),L’Africa romana. Atti del 6. convegno di studio , 16–18 dicembre 1988, Sassari 1989, 66.
[41]
Così Kolb, Fugmann, Tod in Rom (supra, n. 39)
210. Meno convincente Courtney, Musa lapidaria ( supra, n. 11) 120: «you will find my name attached to my
epitaph». Fixa ha in realtà altro valore: cf. E.
Forcellini, Totius latinitatis Lexicon, II, 1831–1835, s.
v. figo, 478–479.
E titulo è ablativo di luogo senza preposizione, fatto
ricorrente nelle epigrafi metriche: cf. J. E. Church, Beiträge zur Sprache der lateinischen Grabinschriften,
München 1901, 75–76.
[42] In Bijdrage tot de studie der Latijnse metriche grafschriften van het heidense Rome. De begrippen « licht » en « duisternis » en verweinte themata , Brussel 1960, G. Sanders ha esaminato svariate iscrizioni contenenti titulus , ma è soprattutto negli studi successivi che egli dimostra di avere preso atto della pluralità di significati della parola.
[43] Così G. Sanders, The Perennial Nature Of The Epigraphic Message From The Late Ancient Community To The Readers Of The Bologna Studium , in: Alma Mater Studiorum: Rivista scientifica dell’Università di Bologna 2 (1989) 37.
[44] Per la datazione e i contenuti di questa epigrafe cf. F. Mainardis, Sulla genesi di CIL V 1863, Arctos 28 (1994) 39–54; G. Bandelli, Le iscrizioni rupestri del passo di Monte Croce Carnico. Aspetti generali e problemi testuali , in: L. Gasperini (ed.), Rupes loquentes , Atti del Convegno internazionale di studio sulle iscrizioni rupestri di età romana in Italia , Roma 1992, 151–205, in particolare 191–192.
[45] Traduzione di L. Mondin in G. Masaro, L. Mondin, La musa funeraria della X regio . Materiali per un censimento, Ostraka 19 (2010) 193–212 (qui 197).
[46] A. D. Melville (transl. by), Ovid. Metamorphoses, with an Introduction and Notes by E. J. Kenney, Oxford, New York 1986, 224.
[47] Questa la posizione di A. D. Melville (transl. by), Ovid. Sorrows of an Exile. Tristia, with Introd. and Notes by E. J. Kenney, Oxford 1992.
[48] Così N. Gardini (ed.), Ovidio. Tristia, Milano 1995, 87.
[49] Così J. André, Ovide. Tristes, Paris 1968, 71.
[50] Cf. N. I. Herescu, Le sens de l’épitaphe ovidienne, in: N. I. Herescu (ed.), Ovidiana, Paris 1958, 420–442. Questa parte del componimento ovidiano pone in ogni caso altre insidie. Alcuni manoscritti presentano al v. 72 in tituli marmore al posto di in tumuli marmore, mentre al v. 77 alcuni di questi o altri esemplari ancora recano in tumulo invece che in titulo. Per spiegare la duplice confusione bisogna ipotizzare a principio della tradizione due lezioni ben distinte: in tumuli marmore al v. 72, in titulo al v. 77. Nel corso della trasmissione l’una è subentrata all’altra, forse anche per lapsus memoriae. Sulla esatta lezione dei due versi cf. G. Luck (herausg., übers. und erkl. von), P. Ovidius Naso, Tristia, Heidelberg 1977, II, 182.
[51] Sul concetto di scrittura esposta cf. A. Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino 1986, 3–7; A. Petrucci,Potere, spazi urbani, scritture esposte. Proposte ed esempi, in: Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde de Rome, 14–17 octobre 1984 (Collection de l’École française de Rome 82), Rome 1985, 85–97; G. Susini, Le scritture esposte, in: G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina, (ed.), Lo spazio letterario di Roma antica, II, La circolazione del testo, Roma, 271–305.
[52] Il testo citato è di Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione (supra , n. 51) 5.
[53] Così H. Häusle, Das Denkmal als Garant des Nachruhms. Beiträge zur Geschichte und Thematik eines Motivs in lateinischen Inschriften , München 1980, 66.
[54] Traduzione di A. Ferrua, I lavori del papa Vigilio nelle catacombe, La Civiltà Cattolica 118 (1967) 143: studio ripubblicato in A. Ferrua, Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane, a cura di C. Carletti, Bari 1991, 332–338. Si noti comunque che Ferrua non traduce affixo. Attraverso questa parola si voleva esplicitare che il carme di Damaso era esposto, in altre parole si trattava di una iscrizione metrica. Per una più recente versione con commento di CLE 917 cf. Carletti, Epigrafia dei cristiani (supra, n. 9), 255–256.
[55] La bibliografia sull’argomento è sterminata. Tra i molti contributi segnalo: J. Mallon, L’archéologie des monuments graphiques , RH 226 (1961) 297–312; D. Manacorda, Archeologia e epigrafia. Problemi di metodo a proposito di CIL , VI, 8960, in: A. Buko, P. Urbańczyk (ed.), Archeologia w teorii i w praktyce, Warszawa 2000, 277–293.
[56] Th. Pekáry, Phidias in Rom. Beiträge zum spätantiken Kunstverständnis, Wiesbaden 2007, 22.
[57] Sul fenomeno di erasione e riscrittura di prodotti epigrafici cf. G. Susini, Epigrafia romana, Roma 1982, 45.
[58] Testo latino e versione italiana di Giardina, Properzio. Elegie (supra, n. 28), 244–245.
[59] Così Suet., Iul. 37, 1. Le fonti sul placard propagandistico di Cesare sono esaminate da I. Östenberg, Veni vidi vici and Caesar’s triumph, CQ 63/2 (2013) 813–827.
[60] Su questo genere di cartelli cf. I. Östenberg, Titulis oppida capta leget. The role of the written placards in the Roman triumphal procession, MEFRA 121.2 (2009) 463–472. Al trionfo dei condottieri romani e all’impiego di cartelli indicanti le città conquistate fa più volte rimando Ovidio, in particolare in trist. IV, 2, 20: … cumque ducum titulis oppida capta leget. L’interpretazione di questo verso e in particolare il significato di titulus non hanno però trovato unanime consenso dei moderni: cf. F. Della Corte, Ovidio. Tristia, I, Genova 1973, 59; J. André, Ovide. Tristes (supra, n. 49), 103–104; Östenberg, Titulis oppida capta leget, cit., 464 e n. 4.
[61] Preferisco rendere con qualche libertà la concinnitas del testo latino, in modo da esplicitarne il significato. Mi sono comunque giovato della traduzione di Veyne: P. Veyne, « Titulus praelatus ». offrande, solennisation et publicité dans les ex-voto gréco-romains , RA 2 (1983) 281, e di G. Vitali,Le vite di dodici Cesari, I, Cesare, Augusto, Tiberio, Caligola, Bologna 1954, 151.
[62] Si potrebbe continuare a lungo nell’elenco di tabelle o cartelli chiamati nelle fonti come tituli. Per ragioni di spazio non posso qui approfondire la questione della denominazione delle etichette librarie, chiamate col termine titulus da Ovidio, secondo almeno quanto afferma buona parte degli studiosi contemporanei in considerazione di un passo di trist. I, 1, 7: nec titulus minio, nec cedro charta notetur. Mi riservo di discuterne in altra occasione.
[63] Cf. Veyne, « Titulus praelatus » (supra, n. 61) 282, n. 7.
[64] Per quanto riguarda i vangeli sinottici, in Marco 15, 26 si ha ἐπιγραφή: καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. Lo stesso in Luca 23, 38: ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’αὐτῷ, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος. In Matteo 27, 37 si legge semplicemente che ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. Il quadro appena fornito induce naturalmente a interrogarsi sulle ragioni per le quali l’autore del quarto vangelo si sia servito del latinismo τίτλος invece che del classico ἐπιγραφή. In generale, non sembra che ἐπιγραφή avesse all’epoca la varietà di significati del termine latino o che come questo fosse usato per indicare la targa iscritta nel suo complesso. Il bisogno di adottare un termine specifico per indicare siffatta realtà spiega forse, allo stesso tempo, la genesi stessa del latinismo e la scelta dell’autore del vangelo di servirsi di tale parola.
[65] Su quest’uso cf. D. Nuzzo, La denominazione della tomba nelle iscrizioni cristiane di Roma. Possibili elementi per la ricostruzione di una identità collettiva , VetChr 42 (2005) 103–134.
[66] Cf. Häusle, Das Denkmal (supra, n. 53) 46. Del resto, Häusle intende e traduce titulus tutte le volte o quasi che lo incontra come Inschrift o Grabinschrift, senza tenere conto di altre possibilità interpretative.
[67] E come si ricava dalla riproduzione fotografica disponibile nelle banche dati epigrafiche consultabili online.
[68] Così la studiosa in Die Römer und der Tod, in: U. Gärtner (ed.), Potsdamer Lateintage 2011–2013. Antike Geschichtsschreibung, Tod und Jenseits, Römische Religion , Potsdam 2015, 61, mentre Pekáry, Phidias in Rom ( supra, n. 56) 22: «Wer diese Inschrift entfernt, den sollen die hier bestatteten Schatten bestrafen».
[69] In molti, ma non in tutti. Proprio perché la parola si prestava a usi e significati diversi a seconda dei contesti, occorre ammettere varie possibilità interpretative di tali espressioni. Questo vale soprattutto per titulum fecit. Se in molte occasioni si sarà voluto dire che questo o quel tale «fece la lapide» o «la stele» o «la tomba» (o, meglio, che la fece realizzare), in una delle due iscrizioni di Filippi (CIL III 633, 2), come visto, si esprime per mezzo delle stesse parole ben altro concetto: si dichiara che Publio Ostilio Filadelfo «ricavò la superficie» per l’iscrizione. In altri casi si sarà pure fatto riferimento alla produzione del testo epigrafico. In generale, il contenuto stesso dell’iscrizione e naturalmente il contesto monumentale di appartenenza sono determinanti a stabilire l’esatto significato della parola nel singolo caso.
[70] Cf. G. Alföldy, Zu den Monumenten der römischen Provinzen auf dem Augustusforum , in: H.-J. Drexhage, J. Sünskes (ed.), Migratio et Commutatio. Studien zur Alten Geschichte und deren Nachleben . Thomas Pekáry zum 60. Geburtstag, St. Katharinen 1989, 226–234.
[71] Sull’epigrafe e i suoi contenuti, oltre a Susini, Fundus Fangonianus (supra, n. 14) 263–269, cf. J. L. Voisin, Les scrupules d’Horatius Balbus. A propos de CIL, XI, 6528, RSA 21 (1991) 23–34.
[72] Cf. G. Susini, Su una chiosa di Gianfranco Tibiletti a CIL, I2, 2123 , in: F. Broilo (ed.) Xenia. Scritti in onore di Piero Treves, Roma 1985, 215–217.
[73] Quando ho iniziato a scrivere questo lavoro, la mia intenzione era di comparare usi e valori di titulus a quelli di inscriptio. Non immaginavo ancora fino a che punto fossero sfaccettati i significati del primo termine. Spero tuttavia di poter procedere al confronto con inscriptio in una prossima occasione.