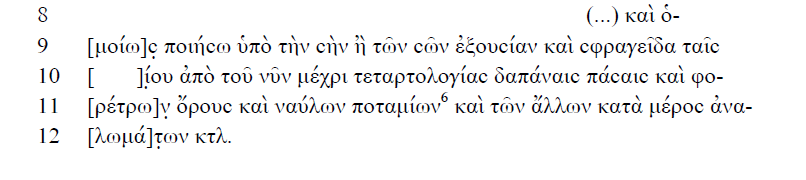
Federico Morelli
Dal Mar Rosso ad Alessandria
Il verso (ma anche il recto) del ‘papiro di Muziris’ (SB XVIII 13167)*
Il papiro, databile al II secolo d.C., è una testimonianza unica sul commercio tra India ed Egitto — e di lì poi verso il resto del Mediterraneo — in età Romana. Esso è stato, dopo la prima edizione di Harrauer e Sijpesteijn [1] (da ora in poi ed. pr.), più volte riconsiderato e discusso[2]. Il testo sul recto è un contratto tra un mercante e un ricco uomo di affari relativo al finanziamento dell’impresa commerciale. È questo documento che con la menzione della località di Muziris, già nota dalla Naturalis Historia di Plinio VI 104, dal Periplus Maris Erythraei 53 ss., e dalla Geographia di Tolomeo, VII 1.8.5, rivela che il papiro tratta di traffici con l’India meridionale. Su questo testo ho da aggiungere solo due osservazioni[3] a quel che è stato scritto dopo l’ed. pr.
Dopo una prima colonna completamente perduta, la parte conservata inizia con la menzione dei fiduciari del creditore, per continuare con l’elenco di una serie di doveri che il mercante-debitore dovrà assolvere nel corso del viaggio di ritorno. Il primo di questi sarebbe il pagamento al cammelliere di l. 2, [δώϲω τ]ῷ̣ ϲῷ καμηλείτῃ ἄλλα (τάλαντα) ρο (δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ϲ̣) ν̣ πρὸϲ ἐπίθ̣εϲιν κτλ. Questo pagamento ha dato, non a caso, problemi a tutti coloro che dopo l’ ed. pr. si sono occupati del papiro. Sotto l’influsso della lettura dell’ed. pr., tutta la ricerca si è diretta a risolvere la difficoltà leggendo cifre o comunque indicazioni monetarie che fossero — secondo i diversi modi di vedere le cose — più credibili di quelle lette dai primi editori.
E tuttavia, a prescindere dall’entità della somma o del carico, difficile è soprattutto capire perché debba esser concordato un pagamento per un cammelliere del creditore, mentre clausole del genere per il resto mancano, né tanto meno sono comuni in contratti di questo genere. Il fatto che il creditore avesse al suo servizio un proprio cammelliere con una carovana di qualche migliaio di animali, dei quali il mercante-debitore avrebbe dovuto servirsi a prezzo stabilito, ha dato adito a considerazioni di diverso genere sul finanziatore dell’impresa, sul suo ruolo reale e sulla natura di tutta l’operazione commerciale.
In realtà di ἄλλα è sicuro solo il primo α. La seconda lettera è confusa, ma si vedono tracce di inchiostro al di sotto del rigo, fino ad un uncino che interferisce con la parte superiore del secondo ο di ὄρουϲ della l. 3: può trattarsi soltanto di uno ξ. La parte alta di questo ξ è diversa da quella che vediamo in ἐξουϲίαν alle ll. 9 e 16; ma uno ξ come il nostro si trova comunque nel πράξεωϲ della stessa l. 16. Dopo una lettera assai stretta, se ne vede un’altra tondeggiante che non può essere α, ma piuttosto ο. Il segno per talenti che seguirebbe è assai diverso da quello usato ripetutamente sul verso: se si astrae da una macchia che sembra unire la parte superiore sinistra a quella superiore destra, la lettera è da leggere piuttosto come χ; il ρ può essere considerato sicuro, ma la lettera arrotondata che segue può bene essere un ε del tipo più corsivo, come ad esempio quelli di ἐμβολῆϲ di l. 6, προϲκρίϲεωϲ di l. 17, o πίϲτεωϲ di l. 23. Dopo, il simbolo delle dracme è da escludere: si tratta di una lettera più complessa e più larga, come ω; infine, il tratto verticale che chiude la parola è isolato: uno ι piuttosto che la parte finale di un ν. Leggo allora: ]δ̣ώϲω [4] καμηλείτηι ἀξ̣ι̣οχρέ̣ωι πρὸϲ ἐπίθεϲιν κτλ. L’oggetto è sempre il carico, come per tutti i verbi che seguono in questa parte del contratto[5]: ἀνοίϲω di l. 3, ποιήϲω di ll. 4–5, ἐμβαλοῦμαι di l. 6, κατοίϲω di l. 7, etc.
Ciò, oltre a restituire una costruzione più logica e uniforme per questa serie di verbi, riporta questa clausola nell’ambito di quello che ci si può aspettare in un contesto in cui ci si impegna a garantire determinate modalità di un trasporto: il cammelliere deve essere affidabile, così come il battello fluviale di l. 7 deve essere ἀϲφαλέϲ, sicuro. Altre persone ἀξιόχρεοι che devono occuparsi di trasporti: CPR V 10.10–11 (Ermopolite, c. 339–340: G. Bastianini, Lista degli strateghi dell’Hermopolites in epoca romana, ZPE 47 [1982] 223 e n. 71) ἀπ̣ενεχθῆναι | τ̣ο̣ύ̣τ̣ο̣υ̣ϲ̣ βούληται μετὰ ἀξιοχρέου φρουρᾶϲ εἰϲ τὴν Ἀντινοέων — dove la traduzione “under sufficient guard” è inadeguata —; P.Panop.Beatty 2.114–115 (300) τριϲχ̣είλια (sic) κανίδια οἴνου ἐ̣μβαλέ̣ϲ̣θ̣αι εἰϲ τὸ (...) | πλοῖον (...) καὶ ἐξαποϲτεῖλαι εἰϲ τὴν ἀνωτέρω Θηβαίδα διʼ [ἐπιμελητο]ῦ̣ ἀξιοχρέου; P.Panop.Beatty 2.281–282 ὀ]κ̣τ̣α̣κοϲίαϲ ἀρτάβαϲ φακῆϲ (...) | διʼ ἐπιμελητοῦ ἀξιοχρέου ἀπόϲτειλον εἰϲ τὴν λαμπρο̣[τάτην Ἀλεξάνδρειαν]; PSI X 1125.3–4 (? 302) φρόντιϲον κομιϲάμενοϲ τὰ π̣[ | ἐπ]ιμελητῶν ἀξιοχρέων.
Evito qui di discutere le conseguenze dell’eliminazione di questo “altro” pagamento al cammelliere del creditore: a cominciare dalla scomparsa del precedente pagamento che esso avrebbe presupposto, perduto nella colonna I del recto.
Un altro punto problematico è alle ll. 8–12 e ha implicazioni per l’interpretazione complessiva del documento. Il mercante-debitore, dopo aver detto che consegnerà le merci nei magazzini della tetarte di Alessandria, continua:
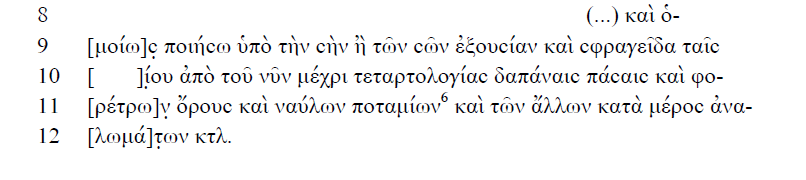
L’interpretazione che mi sembra essere generalmente accettata — con l’eccezione di Casson — è quella di Thür [7]. Egli intende ταῖϲ δαπάναιϲ πάϲαιϲ come un dativo causale, ad esprimere il motivo per il quale il mercante-debitore mette le sue merci sotto la disposizione del creditore: “... e allo stesso modo (cioè, come già a Copto) metterò (le merci) sotto la tua disposizione e il tuo sigillo a causa di tutte le spese” etc. Questa interpretazione pone in realtà dei grossi problemi.
a ) Innanzi tutto problemi di ordine logico: ciò che dà al creditore il diritto di disporre del carico — acquistato con i suoi soldi —, non sono le spese di trasporto sostenute dal mercante con il prestito, ma — e questo era già chiaro a De Romanis [8] — il prestito (quello iniziale o un prestito successivo) in sé e per sé, con il quale, è vero, si sono poi anche sostenute queste spese. Indicare come motivazione le une invece dell’altro significa scambiare l’effetto con la causa, introducendo una pesante ellissi proprio su quello — il fatto di aver prestato i soldi — che è il fondamento dell’ipoteca [9].
b ) La posizione di questa indicazione: non è ad Alessandria che il mercante mette per la prima volta le sue merci sotto la disposizione del creditore. La stessa cosa egli l’ha già fatta prima e allo stesso modo, come puntualizza lo ὁμοίωϲ che introduce questo punto facendone una ripetizione, riferita ad Alessandria, di quel che era stato già detto per Copto; e naturalmente anche questa prima volta ciò era stato fatto a causa del prestito. Ma allora, perché non viene indicato già lì il motivo per cui il creditore può disporre del carico?
La posizione alla fine dell’enumerazione dei doveri del mercante-creditore diventa invece logica se questo dativo si riferisce a tutto quel che lo precedeva: attraversamento del deserto, immagazzinamento a Copto, trasporto sul Nilo, etc. Ciò implica però che il δαπάναιϲ πάϲαιϲ descriva le condizioni alle quali si svolgono le azioni che il creditore si impegna a compiere.
c ) Problemi di ordine grammaticale e formulare: il dativus causae è una forma del dativo strumentale usata nella letteratura per lo più in connessione con sentimenti e stati d’animo[10]. Per quel che riguarda i papiri, il dativo di causa per indicare un motivo oggettivo o soggettivo — soprattutto con verbi di affetto — di un’azione è raro, e si usano piuttosto costruzioni con preposizioni[11]. In particolare con δαπάναι e ἀναλώματα non si può non osservare che i due termini al dativo senza preposizione ricorrono frequentissimamente, da soli o in combinazione, in contesti del tutto privi di ogni valore causale, nei quali qualcuno si impegna a fare e soprattutto trasportare — anche ad una nave [12] — o consegnare qualcosa a proprie spese: il DDBDP dà oltre 150 attestazioni, in formule di vario tipo. Si tratta di un dativo di modo o circostanze concomitanti [13]. In questa situazione, affidare il motivo sul quale si basano i diritti del creditore ad una costruzione poco frequente come il dativus causae invece che ad un normale διὰ τό o simili, per ottenere una formulazione analoga a formule comunissime per esprimere il concetto del tutto differente che le spese saranno coperte da una delle parti di tasca propria, sarebbe stato quanto meno equivoco e poco cauto.
Se si riportano le δαπάναι πᾶϲαι delle ll. 9–10 a quello che è l’uso più comune, e si intende che qui il mercante dovrà provvedere a proprie spese a coprire i costi per le azioni elencate nelle linee precedenti, occorre riconsiderare la lacuna di l. 10. Il [τοῦ πλο]ί̣ου dell’ed. pr., accettato da Thür e Rathbone, lasciava la frase in sospeso tanto da costringere gli editori a presupporne una prosecuzione, che sarebbe stata omessa dallo scriba per aplografia, al πρόϲ di l. 12. Anche paleograficamente, la lettura [τοῦ πλο]ί̣ου dava il problema di non riempire bene la lacuna.
Soprattutto però fa difficoltà il ploion (marino) qui tra articolo e sostantivo e prima delle indicazioni temporali: come è possibile parlare di “tutte le spese della nave da adesso fino alla tetartologia”, se su questa nave il mercante si imbarca solo a Berenice — o in altro porto sul Mar Rosso — per sbarcare al ritorno nello stesso porto, mentre tanto il νῦν della redazione del contratto quanto la tetartologia sarebbero da collocare in Alessandria? Ciò che è perduto nella lacuna iniziale di l. 10 si trova all’interno del sintagma ταῖϲ — δαπάναιϲ πάϲαιϲ, e non è da mettere sullo stesso livello delle singole spese elencate subito dopo. Non abbiamo qui una enumerazione di voci grammaticalmente sullo stesso piano quale “tutte le spese da ora alla tetartologia, (e cioè quelle) della nave[14], e dei costi di trasporto per il deserto, e dei noli fluviali”; dove il ploion sarebbe nominato per primo perché più importante [15].
Per non forzare il testo greco occorre inserire nella lacuna qualcosa che in qualche modo si collochi al di fuori della serie delle singole voci di spesa [16], e completi invece tutta la formulazione specificando da chi tutte queste spese debbano essere sostenute: [ἐκ τοῦ ἰδ]ίου, frequentissimo soprattutto nei contratti proprio per indicare che qualcuno deve assolvere degli impegni a proprie spese. In Preisigke WB I 687 l’espressione figura come punto 12 della voce ἴδιοϲ: “12) Zahlung ἐκ τοῦ ἰδίου, aus eigenen Mitteln, auf eigene Kosten”, già allora con numerose attestazioni dal III a.C. al IV d.C.[17] In particolare in connessione con ἀνάλωμα o δαπάνη, come nel nostro papiro, essa è in P.Brem. 38.11–13 (Ermupoli 118) ἀνήγκαϲέν (sic) με ἐκ τοῦ | ἰδίου δαπάνην ποιῆ|ϲαι; o BGU IV 1123.6 (Alessandria 30 a.C. – 14 d.C.), καὶ ἐξο[δι]άϲουϲιν ἐκ τοῦ ἰδίου ἀμφότεροι ἢ̣ ἑ̣κ̣ά̣τε[ρ]οϲ αὐτῶν τὰϲ ἐϲομέναϲ δαπάναϲ πάϲαϲ; o ancora P.Polit.Iud. 7.6–7 (Eracleopoli prima del 134 a.C.) ἐκ τ̣ο̣ῦ̣ ἰδίου | πλ̣είονα δαπανῶν̣.
Il senso di tutta questa prima parte viene allora ad essere: “... e consegnerò il carico ad un cammelliere affidabile etc. (...), e lo trasporterò attraverso il deserto etc. (...), e lo porrò sotto la tua disposizione etc. (...), e lo caricherò su di una nave sicura etc. (...), e lo trasporterò ai magazzini della tetarte in Alessandria etc. (...), e lo metterò ugualmente sotto la tua disposizione etc. (...), con tutte le spese di tasca mia propria da adesso fino alla tetartologia, sia dei costi del trasporto attraverso il deserto che dei noli fluviali che delle altre singole uscite”.
L’eliminazione del Seeschiff da quelle che pure sono definite come “tutte le spese da adesso fino alla tetartologia” pone a sua volta il problema di come mai proprio il nolo per la traversata — la spesa più rilevante in tutta l’operazione commerciale — non sia menzionato [18]: né come una delle spese che il mercante si impegna in questo contratto a sostenere di tasca propria, e neppure come un motivo per mettere le merci a disposizione del creditore, secondo l’interpretazione che dava Thür di tutta questa parte.
La sola spiegazione alla quale so pensare, tanto banale da essere tautologica, è che qui si tratti solo delle spese che sono nominate: quelle cioè per la fase egiziana conclusiva di tutta l’operazione[19]. Ciò obbliga però a collocare il νῦν che segna l’inizio di queste spese per il trasporto attraverso il deserto e poi sul Nilo — che è poi anche il momento in cui è stato scritto il contratto — non in Alessandria ma in un porto sul Mar Rosso. Alla stessa conclusione era arrivato già in base ad altre considerazioni Casson, che però intendeva diversamente il ruolo delle parti e la natura stessa della transazione[20].
Il contratto allora deve riguardare solo il trasporto dal Mar Rosso ad Alessandria, e non il viaggio per mare o in generale la parte precedente dell’impresa[21]. Questa doveva essere invece oggetto delle κατὰ Μουζεῖριν τοῦ δανείου ϲυγγραφαί delle ll. 12–13, contratte verosimilmente in Alessandria. Probabilmente si tratta qui di un secondo finanziamento. La conclusione di un secondo contratto al ritorno in Egitto per coprire il resto dell’impresa può certo essere spiegata, seguendo Thür, con la “erschöpfte Finanzkraft” dell’ emporos verso la fine del viaggio. Ma forse, si preferiva più semplicemente evitare, con un finanziamento dato in due successivi prestiti, di trasferire in India grosse somme di denaro che in realtà sarebbero servite solo al ritorno in Egitto [22].
Se il recto è stato scritto poco dopo l’arrivo a Berenice o comunque sulla costa egiziana, esso viene ad essere cronologicamente e geograficamente molto vicino, si vedrà, alla scrittura del verso.
Su questo testo sono particolarmente interessanti le considerazioni di De Romanis e Rathbone [23] . Si tratta di un conto relativo al calcolo del valore dei prodotti trasportati presumibilmente nell’ambito della stessa operazione commerciale regolata dal contratto del recto, connesso con la tetarte, l’imposta di importazione del 25 %, e altre quantità prelevate dagli arabarchi.
Secondo l’ed. pr. il carico era costituito da 6 merci: tre di esse sarebbero state indicate nella colonna II, conservata per intero. Essa dà i valori di nardo gangetico, avorio “sano”, e schidai, da intendere come una sorta di tessuti. Dopo i valori delle singole merci, le ultime due linee della colonna danno un riepilogo con il valore complessivo. Questo valore complessivo è stato inteso in modi diversi: come il valore complessivo di tutto il carico trasportato dall’India; come il valore della sua quarta parte, ossia della tetarte; come il valore di quel che rimaneva dopo la detrazione della tetarte. In ogni caso, poiché i valori delle merci della colonna II rappresentano solo un parte minima del valore totale, quelle perdute con la colonna I dovevano rappresentare la parte più importante del carico e di tutta l’operazione commerciale.
Ora, se la colonna II è stata approfonditamente esaminata e discussa, soprattutto nei lavori di De Romanis e Rathbone, la colonna I è ridotta in condizioni assai più miserevoli, ed è comprensibilmente rimasta trascurata: gli stessi editori ne davano una trascrizione soltanto per completezza, e per aiutare se mai l’identificazione di altre parti del papiro che eventualmente avessero potuto essere finite in altre collezioni. Come normale poi per conti ridotti in simili condizioni, anche la lettura di quel poco che si vedeva ha sofferto molto dell’oscurità del contesto. In più, ai tempi dell’ed. pr. il frammento con il quale inizia la parte conservata delle ll. I.17–20 era collocato in posizione erronea e capovolto [24].
Con una revisione del papiro — condotta ripetutamente sull’originale con l’uso del microscopio — è possibile dare un testo più corretto per questa prima colonna. Ciò permette di riconsiderare anche la colonna II, quella conservata meglio, e di chiarirne il contenuto. Do subito una trascrizione rivista delle colonne I e II, seguita da una traduzione, per poi rendere conto e discutere delle mie letture o integrazioni. Si vedrà subito comunque che molti punti, presumibilmente anche importanti, rimangono ancora del tutto oscuri. Non si tratta insomma di una riedizione che risolve le numerose difficoltà di questo documento, ma essenzialmente di una nuova base per una sua migliore comprensione.
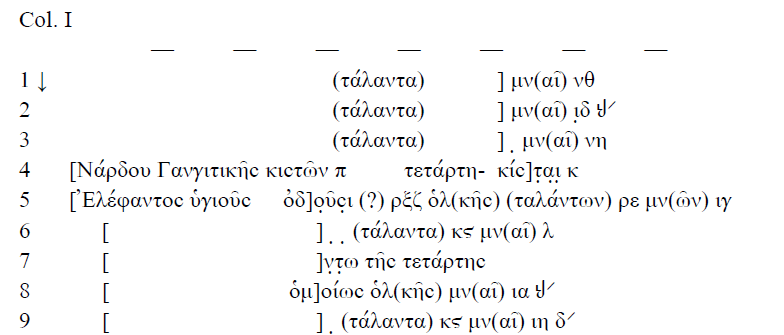
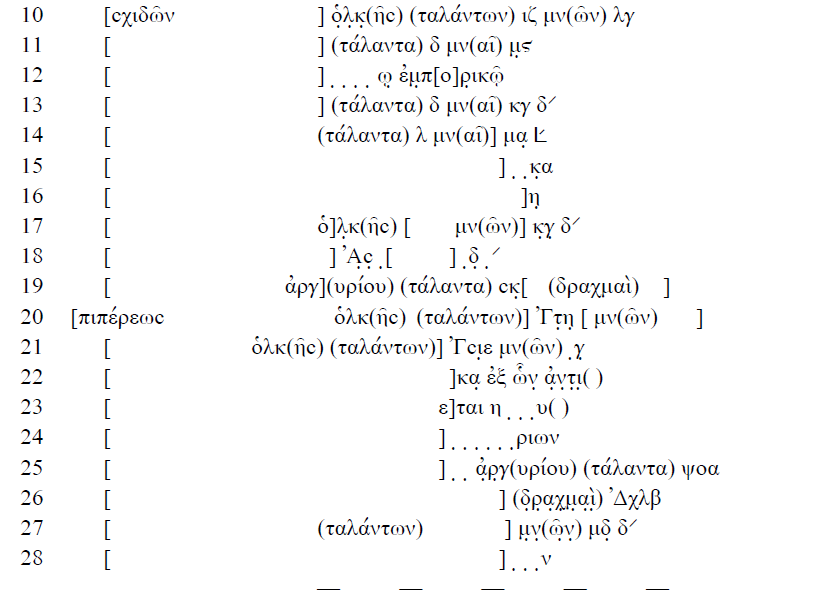
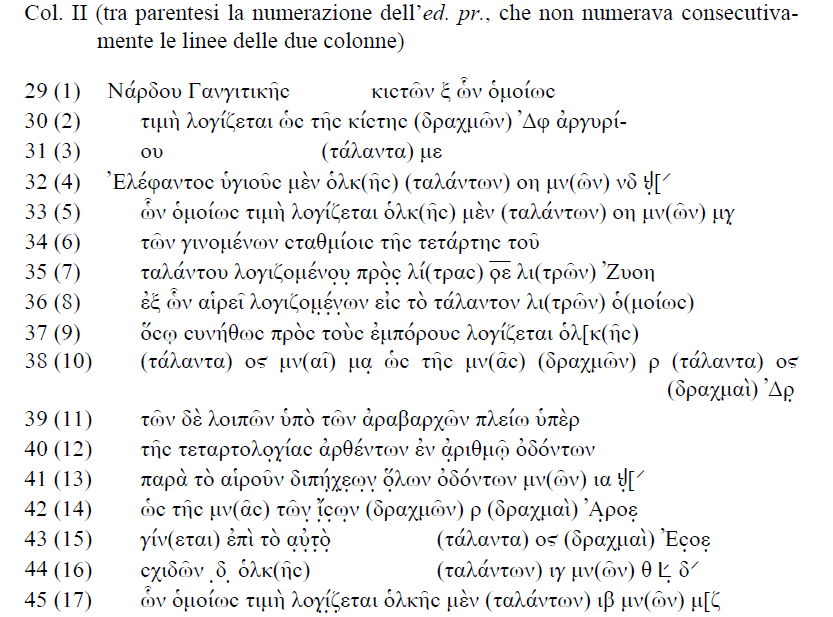
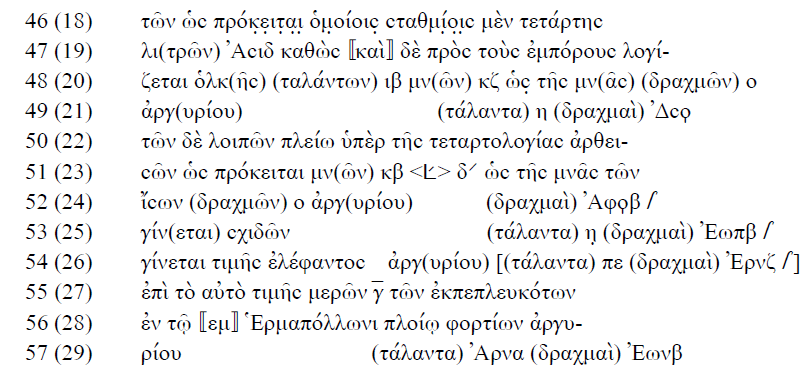
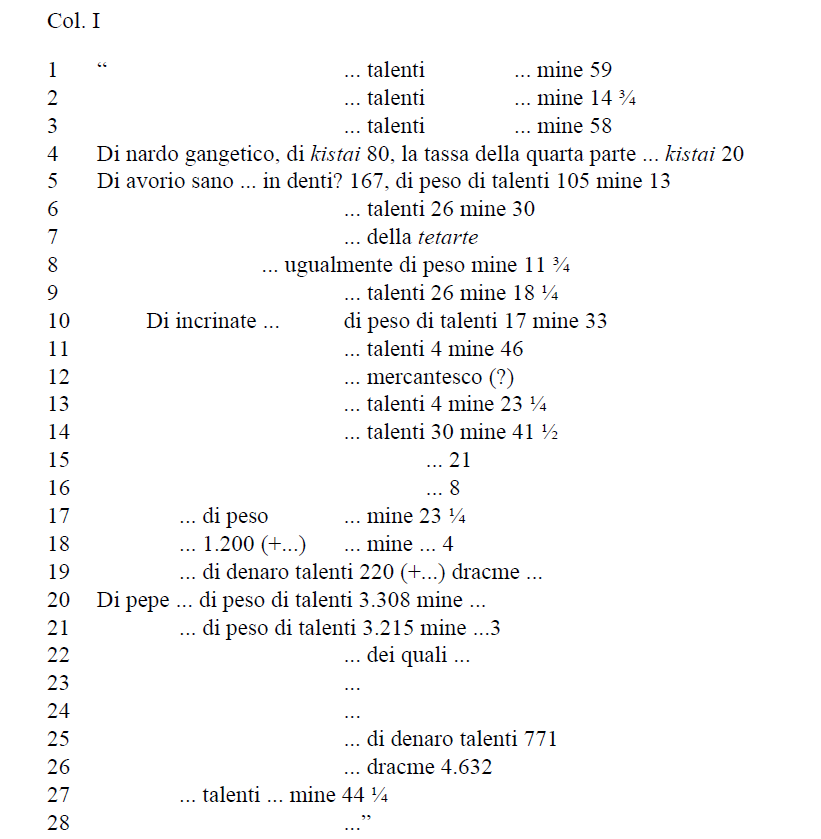
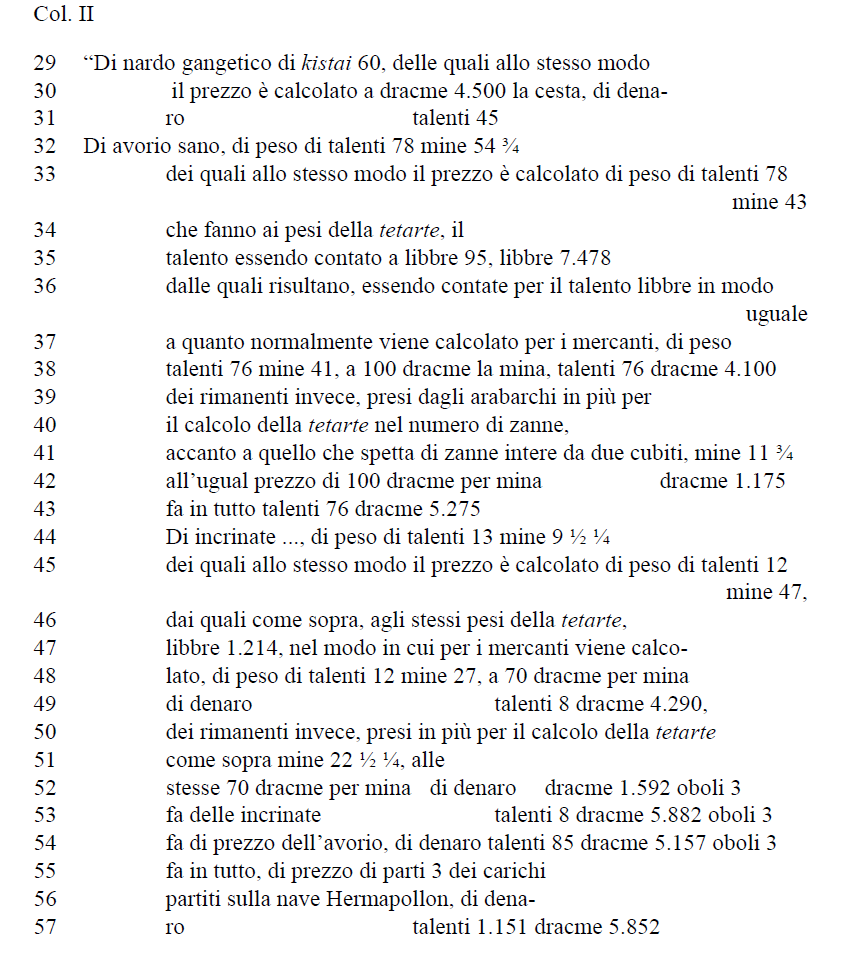
1. τάλαντα): qui e nelle linee che seguono sono incerto sulla scelta tra nominativo e genitivo.
3. Della cifra sul bordo della lacuna si vede un tratto orizzontale, che può essere di γ, ε o ϛ. Si deve trattare di una cifra di talenti che terminava con 3, 5 o 6.
4. Qui e in quello che segue restituisco le ektheseis in base a quel che è possibile constatare nella colonna II, vedi più avanti § 8. Questa restituzione è sicura almeno per le linee a partire da I.20, mentre per questa prima parte con il calcolo delle imposte il sistema poteva essere anche diverso. La sezione di questa merce era ridotta ad una sola linea: manca il prelievo aggiuntivo degli arabarchai, e anche nella colonna II la parte del nardo è ridotta a sole tre linee.
κίϲ]τ̣α̣ι̣: qui un nominativo mi sembra migliore; ma le tracce sono minime, e potrebbero essere anche per il genitivo.
5. ὀδ]ο̣ῦϲ̣ι (?): assai incerto. Molto perplesso mi lascia quello che dovrebbe essere il ϲ: nel nostro papiro lo υ e le altre lettere che terminano con una sorta di uncino in basso sul rigo legano con il ϲ risalendo con un occhiello. Qui si dovrebbe pensare che lo scriba ha tirato via e senza fare l’occhiello è risalito direttamente nel ϲ, ottenendo qualcosa che somiglia piuttosto ad un γ. Ma disturba il fatto che questa esecuzione anomala del ϲ sia da presupporre proprio qui, dove buona parte della parola è perduta e la lettura stessa di quel che rimane è incerta. Alternativamente si potrebbe voler vedere qui la parte finale di ὑγιοῦϲ, ma l’ultima lettera può difficilmente essere il ϲ trascritto nell’ed. pr., e lo spazio della lacuna resterebbe in parte inutilizzato. Non è neppure da escludere che quello che io trascrivo come υ sia in realtà la parte destra di un ν; in questo caso il primo segno sul bordo della lacuna dovrebbe essere il tratto sinistro dello stesso ν.
ρε: contro la lettura ρκ dell’ed. pr. ci sono l’assenza del primo tratto verticale di κ, la leggera convessità del tratto obliquo ascendente, la posizione del tratto orizzontale finale più in alto rispetto alla base del rigo: si confronti il κϛ alla linea immediatamente successiva. La lettura di 105 talenti restaura le relazioni matematiche con le cifre delle linee seguenti e con la sezione dell’avorio ‘sano’ della colonna II, vedi più avanti § 5.
6. ] ̣ ̣: di queste tracce, come del ]ν̣ della l. 7, non si vede più assolutamente niente: il papiro ha perso qui un frammento in anni recenti, come risulta dal confronto con la riproduzione pubblicata con l’ed. pr.
8. ὁλ(κῆϲ): il plurale ὁλ(κῶν) dell’ed. pr. sarà soltanto una svista: gli stessi editori sciolgono per il resto sistematicamente con il singolare ὁλκῆϲ.
9. La tetarte della quantità di l. 5, vedi più avanti § 5.
10. Questa è la quantità totale delle schidai, zanne di elefante incrinate o danneggiate, vedi più avanti n. a l. 41 e §§ 5 e 8. Nella lacuna ci poteva essere come per l’avorio ‘sano’ il numero delle zanne, probabilmente 27 o 28.
11. L’ed. pr. dava qui κϛ per il numero delle mine. Ma la prima lettera, per quanto danneggiata, è un μ: con un tratto obliquo iniziale, più bassa di κ, e con un occhiello all’attaccatura dell’ultimo tratto. 4 talenti e 46 mine restituiscono le corrette relazioni matematiche con le linee che seguono e con la sezione delle schidai nella colonna II: vedi più avanti § 5.
12. ] ̣ ̣ ̣ ̣ ῳ̣ ἐμ̣π[ο]ρ̣ικῷ: forse μ̣έ̣τ̣ρ̣ῳ̣ ἐμ̣π[ο]ρ̣ικῶ, a indicare che queste quantità prelevate per le imposte doganali sarebbero misurate secondo le libbre normali, senza passare attraverso i pesi della tetarte applicati per i ¾ che restano al mercante? Vedi il πρὸϲ τοὺϲ ἐμπόρουϲ con il quale è indicato il corretto tasso di conversione in II.37 e II.47. Non mi sembra possibile invece leggere η al posto di ε, per π̣α̣ρ̣α̣λ̣η̣μ̣πτ̣ικῷ.
13. (τάλαντα) δ: l’ed. pr. leggeva la cifra come κ̣δ, ma per un κ qui, tra il simbolo dei talenti e il δ, manca addirittura lo spazio. Soltanto, il papiro qui era difettoso e il calamo, nel tracciare il simbolo dei talenti, ha lasciato uno sbaffo di inchiostro che congiuntamente alla piccola lacuna che subito segue avrà tratto in inganno gli editori. Qui abbiamo la tetarte delle schidai, vedi più avanti § 5.
14. Dello ] ̣ ὁλ(κῆϲ) α̣ dell’ed. pr. faceva difficoltà l’indicazione di un peso senza alcuna unità di misura: mai nel papiro. Quello che si vede non è ολ, ma la parte destra di un μ. Immediatamente dopo segue un α, con il corpo molto ridotto, il cui tratto destro risale per ridiscendere poi a formare il simbolo per ½. La presenza della frazione indica che doveva trattarsi di mine, da integrare allora subito prima, nella lacuna. Prima ci doveva essere un numero di talenti. Se le schidai sono una sottocategoria dell’avorio contrapposta all’avorio ‘sano’, qui ci deve essere analogamente a II.54 un totale, delle quantità complessive e/o delle tetartai: le 41 ½ mine devono essere parte del totale delle tetartai, di 30 talenti 41 ½ mine. Il numero dei talenti sarà da integrare in lacuna. Probabilmente prima c’era la somma delle due quantità complessive, che darebbero 122 talenti e 46 mine, o meno probabilmente quella delle due quantità di I.6 e I.11, di 31 talenti e 16 mine: per il significato di queste cifre vedi più avanti § 5.
15. κ̣α: anche una lettura μ̣α è possibile.
17–20. Il frammento sulla sinistra è stato ricollocato correttamente solo dopo la prima pubblicazione del papiro. Questo spiega le radicali discordanze dall’ed. pr. per queste linee.
17. κ̣γ̣ δ: ma è anche possibile che quello che io ho trascritto come γ sia solo il prolungamento del tratto inferiore di κ che va a legare con la lettera successiva. La stessa combinazione κγ δ è anche in I.13. In ogni caso qui la frazione mostra che si tratta di mine, che dunque integro nella lacuna. Non so se nella lacuna ci fossero anche dei talenti: lo spazio mi sembra poco.
19. Per le cifre vedi la discussione più avanti § 10.
20. Per la merce vedi più avanti § 9. Possibile lettura alternativa è ᾿Γτι̣ε̣, per 3.315 talenti. Discussione di queste letture e loro implicazioni, più avanti § 9.
21. L’ultima lettera può essere anche uno ϛ.
22. ἀ̣ν̣τ̣ι̣( ): la lettura è ancora quella dell’ed. pr.: a dire il vero ne sono assai poco convinto, ma non ho niente di meglio da proporre, e la lascio nel testo. Non mi sembra possibile leggerci αἱρεῖ, che darebbe ἐξ ὧν αἱρεῖ come in II.36.
27. O forse piuttosto μβ̣ δ ? Neanche una lettura μα̣ δ può essere esclusa.
Col. II
30–31. Da mettere in evidenza il modo in cui lo scriba divide ἀργυρί|ου tra le due linee. Eppure egli avrebbe potuto scrivere la parola abbreviata, come in I.19 e 25, e II.49. Il motivo di questa divisione non è la mancanza di spazio sulla destra, ma la volontà di protrarre la parola sulla linea successiva, per collegarla anche graficamente alla cifra cui essa si riferisce. Analogamente egli si comporta in II.56–57.
32. (ταλάντων): almeno qui il genitivo mi sembra si possa appoggiare sul κιϲτῶν di II.29.
35. Il (γίνονται) dell’ed. pr. qui è stato eliminato da De Romanis, Commercio (n. 23) 24.
36. ὁ(μοίωϲ): la stessa lettura era già stata proposta da De Romanis, Commercio (n. 23) 34 n. 94, che però riferiva lo ὁμοίωϲ all’applicazione dello stesso modo di calcolo in una delle sezioni perdute della colonna I. Io preferisco collegare l’avverbio allo ὅϲῳ che segue immediatamente, “ugualmente a quanto”: cfr. Theon. Math., Commentaria in Ptolemaei syntaxin mathematicam I–IV 408.20: καὶ ἀεὶ ὁμοίωϲ ὅϲῳ ὑπὲρ γῆϲ γίνεται ὁ ἀεὶ φανερὸϲ πόλοϲ, κτλ. Che le stesse conversioni fossero poi applicate anche per alcuni dei prodotti della colonna I è ben possibile, ma il tasso di conversione di 97,5 libbre per talento poteva non essere indicato esplicitamente in nessuna parte del papiro, poiché si trattava del tasso reale applicato dagli emporoi.
38. La lettura μα̣ per il numero delle mine e ᾿Δρ̣ per il numero delle dracme è di De Romanis, Commercio (n. 23) 24, ed è certo da accettare.
41. διπή̣χ̣ε̣ω̣ν̣: nei papiri δίπηχυϲ — che pure ha un paio di centinaia di attestazioni nella letteratura — non è mai attestato; ci sono però gli aggettivi ἡμίπηχυϲ, τετράπηχυϲ, πεντάπηχυϲ, ἑξάπηχυϲ, ἑπτάπηχυϲ, ὀκτάπηχυϲ, ἐννεάπηχυϲ, (δεκά)π(ηχυϲ), (ὀκτακαιδεκά)π(ηχυϲ), ἐνενηκονταεξάπηχυϲ. Due cubiti o poco più di 1 m sono perfetti come misura per le zanne di elefante indiano; e almeno in epoche più recenti le zanne venivano raggruppate e trattate secondo le dimensioni. Merck’s Warenlexikon. Beschreibung der im Handel vorkommenden Natur- und Kunsterzeugnisse, namentlich der Kolonial-, Material-, Droguerie- und Farbwaren, Mineralien- und Bodenprodukte, chemisch-technischer und anderer Fabrikate , A. Beythien, E. Dressler (Hrsg.), (7. Aufl.) Leipzig 1920, 107 (le spaziature sono mie): “Die Zähne werden nach der Größe sortiert und bewertet, außerdem richtet sich der Preis danach, ob sie schwach oder stark gekrümmt, rissig, frisch oder alt sind und ob die Höhlung sich von der Wurzel weit in das Innere erstreckt. Mit zunehmendem Alter füllt sich die Höhlung immer mehr mit Zahnmasse an. Völlig ausgewachsene afrikanische Zähne sind 15 – 18 dm lang und bis 50 kg schwer. Stücke von 20 – 24 dm Länge und 75 – 85 kg Gewicht kommen selten vor. Die asiatischen Zähne werden nicht über 9 – 12 dm lang und 25 – 30 kg schwer”. Di dimensioni unitarie sono anche le 2.000 zanne di elefante da tre pecheis, ἐλεφάντων ὀδόντεϲ διϲχίλιοι τριπήχειϲ di Diodoro Siculo 31.8.12.
42. Qui il papiro è conservato, ma dell’[ἀργ(υρίου)] dell’ed. pr. non si vede traccia. L’importo di denaro di II.38 mostra che esso non è neppure necessario.
43. Correttamente qui De Romanis, Commercio (n. 23) 24, legge Ἐϲοε per il numero delle dracme.
44: ϲχιδῶν̣ ̣δ ̣: il δ è visibilmente legato ad una lettera che lo segue, il che fa escludere che qui ci fosse il numero delle zanne. Del resto 54 pezzi sarebbero un numero troppo alto. La lettura δέ proposta da Rathbone, The ‘Muziris’ papyrus (n. 23) 44 n. a l. 16, e 45, darebbe un ottimo senso: essa oppone le zanne incrinate a quelle sane di II.32, non a caso seguite da un μέν che altrimenti rimarrebbe in sospeso. Prima di δέ però si vede ancora una lettera, quella che gli editori leggevano come il ν della cifra νδ, che rimarrebbe inspiegata. Il problema può essere risolto con una lettura ϲχιδί̣ων̣ δέ̣ che ne farebbe la finale del genitivo plurale. Mi fa difficoltà però il fatto che in II.53 si legge chiaramente ϲχιδῶν.
θ ̣ δ: fa difficoltà. Di regola lo scriba usa il segno per i ¾, non la combinazione delle frazioni ½ ¼, e qui il simbolo per ½ è appena visibile. Singolarmente, il problema è ancora più evidente in II.51, dove tra κβ e δ non riesco a vedere assolutamente nulla; anzi, non c’è neppure lo spazio per immaginare che ci fosse qualcosa, ancorché adesso completamente svanito. Eppure la frazione ½ è richiesta dalla matematica: solo con 22 ½ ¼ mine si ottiene, al prezzo di 70 dracme per mina, il valore indicato di 1.592 ½ dracme; e 22 ½ ¼ mine in II.51 presuppongono 9 ½ ¼ mine in II.44. In più ci sono le relazioni con i dati della colonna I, vedi più avanti § 5. Che dire? Forse lo scriba aveva tralasciato il segno per ½, e lo ha inserito — ma solo in II.44 — in un secondo tempo. Ciò implicherebbe che egli non calcolava parallelamente alla stesura del conto: altrimenti, omettendo una frazione, non avrebbe ottenuto e scritto l’importo di denaro corretto. Egli doveva invece copiare da un conto o almeno da appunti già scritti.
46. L’ed. pr. qui aveva τῶν ὡϲ πρό̣κ̣(ειται) γ̣ι̣ν̣(ομένων) ἐ̣κ̣ τ̣οῦ̣ μ̣έ̣ρου̣ϲ ϲταθμίοιϲ κτλ., con abbreviazioni per i verbi πρόκ(ειται) e γιν(ομένων). Ma lo scriba usa le abbreviazioni molto parsimoniosamente, solo con unità di misura e monetarie — (τάλαντα), (δραχμαί), μν(αῖ) e λί(τραι); non però le meno frequenti κίϲται —, o con terminologia contabile comunissima: ἀργ(υρίου), ὁλκ(ῆϲ) o ὁλ(κῆϲ), γί(νεται): il γί(νεται) in particolare è forma comunissima nella contabilità, che non può sostenere l’introduzione della stessa abbreviazione per il participio γινομένων. Ancora, nell’ed. pr. farebbe difficoltà lo ἐκ τοῦ μέρουϲ: non necessario, come mostra la formulazione parallela di II.34, bruttissimo linguisticamente, e di fatto eliminato in traduzioni come quella di De Romanis, Commercio (n. 23) 57 l. 18. Ma le difficoltà più grosse sono paleografiche: di πρόκειται sul papiro si vedono bene le prime tre lettere, mentre delle altre rimane abbastanza per dire che la parola era scritta per esteso. Il resto della lettura è difficilmente riconoscibile, se non per le ultime lettere ρ̣ου̣ϲ̣, dove però io vedo piuttosto ιοιϲ̣; delle lettere ομ̣ο che precedono soltanto il μ è incerto a causa della pronunciata ansa del primo tratto: fenomeno che in questo testo si ritrova anche altrove, ma mai così forte.
51. μν(ῶν) κβ <> δ: del simbolo per ½ non vedo né tracce di inchiostro né lo spazio dove esso avrebbe potuto trovarsi. Vedi sopra n. a II.44 e più avanti § 5.
54. [(τάλαντα) πε (δραχμαὶ) ᾿Ερνζ ]: il totale delle zanne integre e di quelle incrinate.
55. μερῶν γ̅: il tratto verticale inclinato e rettilineo, senza l’incurvatura della parte bassa verso destra che è distintiva di ϛ, assicura che si tratta di un γ. Si confrontino le due lettere, una sopra l’altra, alla fine di I.10 e I.11. Vedi anche i γ finali di ἀργ(υρίου) in I.25, II.49, 52, 54.
57. (τάλαντα) ᾿Αρνα (δραχμαὶ) ᾿Εωνβ: l’ed. pr. dava 1.154 talenti e 2.852 dracme. Ma in questa scrittura il Δ ha la forma maiuscola, posata e angolosa, non quella più corsiva che potrebbe renderlo simile ad un α. Quello che poi gli editori avevano considerato come il primo tratto del Β è in realtà l’attacco dell’apice delle migliaia, che per ε parte dalla base della lettera.
L’opinione che il conto riguardasse i ¾ del carico, contro le 6 parti dell’ed. pr., era già nell’articolo di Rathbone, The ‘Muziris’ papyrus (n. 23) 44 n. a l. 27, e 45: leggendo γ in II.55, là dove l’ed. pr. aveva uno ς, egli pensava alle 3 parti che del carico complessivo sarebbero rimaste al mercante dopo la detrazione delle tasse doganali. In effetti un γ avevo visto anch’io alla prima lettura superficiale del papiro. E un γ è a ben vedere la sola lettura paleograficamente possibile. Con un γ si ottiene un greco molto migliore per questa annotazione finale: “del prezzo di 3 parti dei carichi partiti sulla nave Hermapollon” etc. Gli editori invece dovevano tradurre “Insgesamt von den 6 (Fracht)teilen, die im Schiff des Hermapollon exportiert worden sind, als Ladegut” etc.: facendo del τῶν ἐκπεπλευκότων un participio attributivo del μερῶν, che però essi si sentivano di dover precisare con il Fracht tra parentesi; e facendo un’apposizione — o un predicativo se lo si fa dipendere dal verbo —, “als Ladegut”, del φορτίων che altrimenti sarebbe rimasto inutile e in sospeso. In realtà l’articolo τῶν va con i φορτία: τῶν ἐκπεπλευκότων ἐν τῷ Ἑρμαπόλλωνι πλοίῳ φορτίων costituisce un’unità, retta dal genitivo che la precede μερῶν.
È possibile che la lettura del numero 6, per quanto meno immediata, sia stata preferita dagli editori per il fatto che, con 3 prodotti nella colonna conservata e una colonna precedente nella quale si leggeva assai poco, poteva essere presumibile che altri tre prodotti si trovassero nella colonna I. Che in I.21 iniziasse una sezione analoga a quelle della colonna II era stato già visto, ad esempio, da De Romanis, Commercio (n. 23) 35 n. 97, e da Rathbone, The ‘Muziris’ papyrus(n. 23) 43. La colonna I doveva allora seguire lo stesso schema della colonna II, relativamente a tre prodotti diversi.
Questo è in certa misura vero solo per la parte inferiore della colonna. La prima parte invece è diversa, e dà la chiave per la comprensione di tutto il conto. I numeri di I.5–13, meglio conservati che altrove, mostrano delle relazioni inequivocabili: le 11 ¾ mine di I.8 sommate ai 26 talenti e 18 ¼ mine di I.9 danno come risultato i 26 talenti e 30 mine di I.6[25]. Ma c’è di più: i 26 talenti e 18 ¼ mine di I.8 sono esattamente la quarta parte della quantità totale di 105 talenti e 13 mine indicata per la merce di I.5 [26]: si tratta insomma della parte detratta per il pagamento della tetarte, menzionata infatti in I.7.
Relazioni ben definite sono riconoscibili anche tra le cifre delle linee seguenti: i 4 talenti e 23 ¼ mine di I.13 rappresentano esattamente ¼ dei 17 talenti e 33 mine di I.10[27]. La cifra che si trova tra queste due, i 4 talenti e 46 mine di I.11, ha anch’essa una relazione con le altre, si vedrà, analoga a quella dei 26 talenti e 30 mine di I.6 con le altre cifre delle ll. I.5–9.
Si tratta insomma di due brevi sezioni, strutturate in qualche modo in maniera simile. Si noterà subito anche che queste due sezioni si differenziano da quelle meglio conservate della colonna II per il fatto di dare la tetarte, non indicata invece per le altre merci. Quello che è più interessante però sono le relazioni di queste due sezioni con quelle della colonna II. Infatti:
105 talenti 13 mine di I.5 : 4 × 3 = 78 talenti 54 ¾ mine indicate per l’avorio in II.32.
11 ¾ mine di I.8 = 78 talenti 54 ¾ mine di II.32 – 78 talenti 43 mine di II.33. Si tratta insomma della stessa quantità che si ritrova in II.41 come sovrappiù preso dagli arabarchi.
E ancora:
17 talenti 33 mine di I.10 : 4 × 3 = 13 talenti 9 ¾ mine delle schidai di II.44.
4 talenti 46 mine di I.11 – 4 talenti 23 ¼ mine di I.13 = 22 ¾ mine di II.51. Queste 22 ¾ mine sono uguali alla differenza tra i 13 talenti 9 ¾ mine di II.44, e i 12 talenti 47 mine di II.45: si tratta anche qui della quantità presa in più dagli arabarchi.
In questo modo abbiamo finalmente tutti gli elementi del problema:
alle linee I.5 e I.10 le quantità totali di avorio ‘sano’ e di schidai;
alle linee I.9 e I.13 le loro tetartai;
alle linee I.6 e I.11 le somme di tetartai e quantità per gli arabarchi: di tutto quello cioè che — nominalmente — viene tolto dalle quantità originarie.
La quantità per gli arabarchi è indicata a parte per l’avorio in I.8; non sembra esserlo invece per le schidai.
Nella colonna II sono considerati i restanti ¾, quelli che rimangono al mercante, per i quali viene poi calcolato il valore in denaro.
Se nella parte superiore della prima colonna c’erano le quantità totali e le parti prelevate per le tasse doganali, subito prima dell’avorio dovremmo avere indicazioni dello stesso genere per le 60 kistai del nardo gangetico di II.29: e infatti in I.4 abbiamo un numero 20: le 20 kistai che rappresentano ¼ delle 80 che dovevano costituire la quantità totale, e che dovevano trovarsi sulla stessa linea. Anche qui dunque, quantità totale e tetarte nella prima colonna, e rimanenti ¾ con il valore nella colonna II. Per il nardo le prime due indicazioni sono concentrate in una stessa linea, allo stesso modo in cui anche nella colonna II la parte relativa a questo prodotto è molto più sintetica e semplice che per l’avorio.
Possiamo allora dire con certezza che Rathbone aveva ragione di ritenere che le quantità della colonna II fossero i ¾ del carico, le parti che rimanevano al mercante tolte le tasse di importazione.
Poiché il calcolo del valore della merce riguarda solo i ¾ del carico e non la tetarte, è evidente che esso non ha alcun rapporto con il pagamento delle imposte doganali. Il mercante o qualcun altro attivo nell’impresa commerciale intende sapere quale è il valore di quanto è rimasto del carico al netto delle tasse, uguale quale sia il motivo di questa operazione. La tetarte invece è stata detratta nella colonna I in natura, senza alcuna conversione o indicazione di un valore monetario — come invece ci si aspetterebbe se essa fosse stata riscossa in denaro —, anche se questo, si vedrà, non significa necessariamente che essa non fosse più materialmente insieme al resto.
In più viene detratta anche una piccola quantità presa dagli arabarchi. Per questa quantità, che nella colonna I era stata sommata alla tetarte, il valore viene calcolato, e per di più viene sommato a quello della parte del mercante. Questa operazione può a prima vista confondere le idee, ma è invece essenziale per capire il procedimento.
Prima che se ne possa calcolare il valore, quello che rimane dei ¾ del mercante deve passare attraverso una doppia conversione da talenti in libbre e poi di nuovo da libbre in talenti: secondo due tassi di conversione diversi, di 95 e poi 97,5 libbre al talento, riconosciuti e discussi da De Romanis e da Rathbone[28]. Poiché ormai il mercante ha dietro di sé il calcolo delle tasse doganali con l’intervento dei pesi della tetarte, questa conversione deve servire a riportare in una quantità reale una quantità di partenza che evidentemente reale non è, e per questo non può essere la base per calcolare il valore della merce. Il passaggio attraverso una conversione a 95 libbre per talento, contro quella reale di 97,5, era stato un artificio contabile con il quale gli arabarchi avevano assegnato al mercante meno dei ¾ matematici del carico[29].
Immaginabili sono diversi procedimenti, comunque uguali nei risultati. Gli arabarchi potevano aver pesato il carico, ad esempio quello di avorio ‘sano’, ricavandone una quantità di 105 talenti e 13 mine. Tradotto in libbre ad un tasso di 95 libbre il talento, si sarebbe trattato di 9.995,58 libbre contro le 10.258,625 libbre reali che si sarebbero ottenute al tasso corretto di 97,5. Ciò poteva avvenire con l’uso di pesi maggiorati, o piuttosto semplicemente con un calcolo matematico partendo dal reale peso in talenti. In ogni caso queste 9.995,58 libbre (fittizie) erano state divise in due parti: la tetarte, di 2.498,9 libbre (sempre di quelle sopravvalutate) o 26 talenti e 18 ¼ mine (teorici); le 7.496,69 libbre da assegnare al mercante che rappresenterebbero i ¾ del carico. Questa quantità doveva infine essere pesata in libbre, reali.
Oppure, la quantità di 105 talenti e 13 mine poteva essere divisa in una tetarte da 26 talenti e 18 ¼ mine, e nella parte del mercante di 78 talenti e 54 ¾ mine. Questa quantità sarebbe stata convertita in libbre al tasso di 95 libbre il talento, e quindi pesata in libbre — ovviamente di quelle giuste — al mercante.
In ogni caso, poiché queste libbre da 1/95 di talento sono ‘più pese’ delle altre, gli arabarchi si ritrovano a trattenere un avanzo. Il mercante invece si ritrova con una quantità di avorio che solo nominalmente corrisponde ai ¾ del carico, di 78 talenti e 54 ¾ mine. Per proseguire i suoi affari, questa quantità nominale ‘secondo la bilancia della tetarte’ non gli è di nessuna utilità. Egli la deve tradurre nella quantità reale, secondo le misure utilizzate dagli emporoi come lui negli scambi commerciali. Per conoscere questa quantità reale egli deve rifare all’inverso il procedimento applicato dagli arabarchi: prima egli converte la sua quantità nominale di 78 talenti e 54 ¾ mine in libbre secondo il tasso di 95 libbre per talento, ottenendo così il numero di libbre che egli ha effettivamente. Da queste egli può, applicando il tasso di conversione corretto, calcolare il vero peso del suo carico nelle misure che lui e i suoi colleghi usano normalmente, e cioè i talenti e le mine.
È da chiarire qui che, se la parte che resta al mercante è inferiore ai ¾ reali del carico, la parte prelevata per la tetarte deve ovviamente essere superiore alla quarta parte reale, ossia ai 26 talenti e 18 ¼ mine indicati in I.9. Certamente, è ben possibile e anche probabile che al fisco andassero davvero i 26 talenti e 18 ¼ mine registrati, e che la parte prelevata in più fosse trattenuta a qualche titolo dagli ufficiali incaricati della riscossione. Tutte queste cose però non sono di alcun interesse per chi ormai, come il mercante, abbia già subito l’imposizione fiscale e intenda calcolare il valore di quel che rimane al netto delle tasse: egli può allora registrare semplicemente il prelievo secondo il suo peso nominale, in questo caso inferiore a quello reale.
Prima di fare il calcolo il mercante ha sottratto dai suoi ¾ teorici una piccola quantità, che chiamerò da qui in avanti la ‘parte degli arabarchi’. Questa quantità ha fatto problemi a chi occupandosi di questo testo ha pensato si trattasse di un’ulteriore imposta. Essa in effetti sembra sfuggire ad ogni logica di percentuali. Per l’avorio ‘sano’ si tratta di 11 ¾ mine, corrispondenti, secondo la cifra presa a riferimento, alle seguenti percentuali (arrotondate al terzo decimale):
0,186 % di 105 talenti e 13 mine (totale della merce)
0,744 % di 26 talenti e 18 ¼ mine (tetarte)
0,248 % di 78 talenti 54 ¾ mine (¾ del mercante)
Per le schidai 22 ¾ mine rappresentano:
2,160 % di 17 talenti e 33 mine (totale)
8,642 % di 4 talenti e 23 ¼ mine (tetarte)
2,881 % di 13 talenti e 9 ¾ mine (¾ del mercante)
Per il nardo gangetico poi questa detrazione aggiuntiva non è affatto applicata: ciò costringeva a pensare che questa gabella colpisse solo determinate merci, senza però che fosse possibile riconoscere il motivo di questo differente trattamento.
Ma il problema non è solo di percentuali. Più grave è il fatto che anche come valore assoluto le 1.175 dracme dell’avorio ‘sano’ siano un importo inferiore alle 1.592,5 dracme delle schidai. Eppure l’avorio ‘sano’ è un prodotto di per sé più costoso, e ha un valore complessivo che arriva a quasi dieci volte quello delle schidai. Se mai si può osservare che, proprio in termini di valori assoluti, i due importi non sono molto distanti; e anche le quantità di 11 ¾ e 22 ¾ mine (c. 6,169 kg e c. 11,944 kg), per quanto l’una sia quasi doppia dell’altra, rimangono su ordini di grandezze confrontabili: molto più, almeno, di quanto lo siano i valori percentuali.
Per questa ‘parte degli arabarchi’ il mercante può calcolare il valore allo stesso prezzo del resto senza passare attraverso le libbre con la doppia conversione: evidentemente essa è una quantità alla cui natura — reale o fittizia — egli non ha (più) alcun interesse. Non solo: il valore di questa piccola quantità viene sommato al valore della parte del mercante. Il mercante insomma, al momento in cui stende il conto, ha a che fare con del denaro.
Perché mai, se si tratta di un’imposta, egli la somma come valore in denaro alla parte di carico che gli rimane? Eppure nella colonna I la stessa quantità è sommata alla tetarte, il che indica che davvero essa segue la stessa sorte dell’imposta doganale. Anch’essa, come la tetarte, va al fisco.
La spiegazione che elimina questa apparente contraddizione può essere soltanto una: ci troviamo di fronte ad uno scambio. Materialmente questa quantità va davvero agli arabarchi, ma essi la riscattano al mercante pagandogli il suo valore in denaro. Egli ne somma il valore a quello dei suoi ¾ poiché in effetti esso fa parte del valore della sua merce, anche se egli non dispone più, materialmente, di questa quantità di avorio. E poiché essa è già stata riscattata come se il suo peso fosse stato reale, indipendentemente dagli artifici contabili applicati per il prelievo fiscale, il mercante non la deve convertire in libbre per conoscerne il valore in denaro: denaro che egli ha già ricevuto o riceverà secondo l’importo stabilito e che quindi già di per sé rendeva ormai inutile qualsiasi riconsiderazione di questa ‘parte degli arabarchi’, indipendentemente da quale ne fosse stata la natura. Si tratta in definitiva della sola quantità — per altro minima — per la quale gli non abbia avuto uno svantaggio, anzi [30].
Che questo prelievo sia una cosa diversa da un’imposta, un dazio, o una gabella[31], è detto in II.39–41, come queste linee risultano dalla nuova lettura: si tratta della parte che gli arabarchi hanno dovuto inevitabilmente prelevare in sovrappiù nel numero delle zanne, accanto a quel che spettava di zanne intere della lunghezza di due cubiti [32].
Si è già visto come erano stati calcolati i ¾ della parte del mercante. In libbre si sarebbe trattato di 7.496,6875 libbre, e cioè, calcolando a 323 g la libbra, 2.421,43 kg. Ora, i 105 talenti e 13 mine per 167 zanne indicati in I.5 danno un peso medio di poco inferiore ai 20 kg per zanna. Con un’unità minima di questo genere, indivisibile e di dimensioni grosso modo costanti, era difficile mettere insieme un numero di pezzi che dessero esattamente la quarta parte della quantità totale. Gli arabarchi devono allora — pagando però il corrispettivo valore in denaro — prelevare una quantità leggermente superiore: le 11 ¾ mine della ‘parte degli arabarchi’ dell’avorio ‘sano’ corrispondono a c. 6 kg: meno della terza parte del peso medio di c. 20 kg per zanna. Per le schidai 22 ¾ mine sono uguali a c. 11,94 kg: il che significa che non si trattava propriamente di frammenti, ma di zanne in qualche modo danneggiate, incrinate, o solo parzialmente spezzate. L’alternativa a questo modo di procedere sarebbe stata segare una zanna in due, sperando di indovinare il peso giusto per le due parti — e compromettendone però il valore —; oppure prelevare una tetarte un po’ più bassa, lasciando che fosse il mercante a conguagliare in denaro quel che mancava per arrivare alla quarta parte esatta del carico.
Tutto ciò implica inevitabilmente che la tetarte fosse riscossa in natura [33]. Con pagamenti in denaro sarebbe stato possibile calcolare con esattezza matematica le diverse parti, uguale di quale merce. Per il nardo gangetico invece il problema non si pone comunque: di 80 ceste se ne prelevano 20, e la divisione è fatta. Poiché questo prodotto è computato non in peso ma in ceste evidentemente omogenee, non è neppure possibile applicare artifici come conversioni in libbre secondo tassi fittizi.
Probabilmente questo arrotondamento per eccesso che dà luogo a questa ‘parte degli arabarchi’ era un fenomeno limitato a poche merci difficilmente divisibili. Lo ὁμοίωϲ di II.33 sembrerebbe, è vero, far pensare che nella parte precedente peggio conservata ci fosse almeno un altro prodotto per il quale si applicava la stessa procedura. O forse qui ὁμοίωϲ è da intendere diversamente, in riferimento piuttosto alle conversioni con la libbra applicate alla parte introdotta dallo ὧν immediatamente precedente? Si può rilevare che la spiegazione accurata che si dà in II.39–41 di questo sovrappiù fa pensare che, almeno in questa forma, esso fosse qualcosa di nuovo nel papiro. In II.50–51, dove la stessa procedura è ripetuta per le schidai, essa è soltanto accennata, mentre lo ὡϲ πρόκειται rimanda alla spiegazione più dettagliata della sezione dell’avorio ‘sano’.
Prima di continuare a discutere dei modi di calcolo e riscossione della tetarte, si devono chiarire per quanto possibile natura, quantità, e valori degli altri prodotti.
Contro l’interpretazione accettata comunemente, per cui le schidai sarebbero state balle di tessuti [34], Rathbone, The ‘Muziris’ papyrus (n. 23) 45, pensava a zanne di elefante in frammenti, in schegge, contrapposte alle zanne integre, l’avorio ‘sano’ di II.32. Conseguentemente egli integrava nella lacuna di II.54 il totale dei valori di avorio ‘sano’ e schidai. Correttamente, come mostra una serie di argomenti che si vanno ad aggiungere alle osservazioni già fatte da Rathbone.
L’interpretazione delle schidai come una sorta di avorio è la sola che si concilia con la disposizione delle linee sul foglio. La linea che introduce il nardo e quella che introduce l’avorio sono in ekthesis; secondo la prassi che, quando è seguita, distingue coerentemente le parti di un conto articolando le registrazioni secondo una gerarchia di sezioni e sottosezioni. La parte delle schidai invece è incolonnata con le altre registrazioni della sezione dell’avorio ‘sano’: graficamente essa si inquadra piuttosto come una parte, una sottorubrica della sezione dell’avorio [35].
Poiché le schidai sono zanne di elefante, anche se danneggiate, esse sono più difficilmente divisibili di un prodotto come il nardo gangetico: ciò spiega perché per esse si arrotondi la quantità al numero di zanne come per l’avorio ‘sano’.
Ancora, soltanto se le schidai sono anch’esse zanne di elefante, la ripetizione in II.54 di un totale per l’avorio — si noti bene, qui genericamente e senza la specificazione ὑγιοῦϲ — subito prima del totale finale viene ad avere un senso. Già gli editori rilevavano la stranezza di questa apparente ripetizione dopo una sezione che sarebbe stata dedicata alle stoffe[36]. In realtà non si tratta di una ripetizione, ma del totale del valore di tutto l’avorio, dopo i valori delle due diverse categorie.
E infine: che avorio ‘sano’ e schidai fossero prodotti dello stesso genere sembra confermato da I.14: qui doveva esserci il totale delle loro tetartai e probabilmente anche delle loro quantità complessive, rispettivamente in I.5–9 e I.10–13; allo stesso modo in cui in II.54 ci doveva essere il valore totale delle parti rimaste al mercante: vedi sopra n. a I.14.
Passando alle merci che non hanno lasciato tracce nella colonna II, ci si muove su un terreno molto più incerto. In I.20–21, con l’indicazione di due cifre molto vicine tra loro, deve iniziare la sezione di una nuova merce. Ciò era stato già visto da De Romanis e da Rathbone [37], che pure avevano a disposizione solo la seconda delle due cifre. Con oltre 3.300 talenti questa merce rappresenta certo la parte più grossa del carico complessivo della Hermapollon.
Per questa merce il papiro dà anche un valore in denaro: quello che si vede in I.25 è chiaramente il simbolo dei talenti, non delle dracme; e quello che lo precede non può essere altro che l’abbreviazione di ἀργ(υρίου)[38]: come in II.30–31, 49, 52, 54, 56–57. Abbiamo allora una somma di denaro molto elevata, di almeno 771 talenti.
Un calcolo grossolano — ignorando cioè i possibili artifici contabili e le parti in mine per la quantità e in dracme per il valore — mostra che un valore di 771 talenti o 4.626.000 dracme per una quantità intorno ai 3.215 talenti presuppone un prezzo di c. 23,98 dracme per mina. Con le altre quantità che si potrebbero considerare il risultato cambia assai poco: sulle 23,3 dracme la mina per la quantità più elevata di I.20, intorno ai 3.310 talenti; quantità che per altro sarà stata difficilmente la base del calcolo. Volendo considerare i 3.215 talenti di I.21 come la quantità nominale — come è per l’avorio di II.32–33 e II.44–45 — si andrebbe ad un peso reale di c. 3.132 talenti e 34 mine, per un prezzo di c. 24,6 dracme per libbra. Tutti dati approssimativi, come è la base che abbiamo a disposizione per il calcolo. È verosimile in ogni caso che anche questo prezzo, come gli altri della colonna II, fosse espresso in un numero tondo o comunque non complesso di dracme[39]; si può concludere allora che il valore della merce di questa sezione doveva essere calcolato ad un prezzo di 24 dracme per mina.
Questo prezzo dà, se tradotto in unità romane, c. 3,7 denari la libbra. Questo valore è singolarmente vicino ai 4 denari la libbra indicati da Plinio nella Naturalis Historia XII 28 per il pepe nero, prodotto e importato proprio dalla regione da dove provengono le merci caricate sulla Hermapollon. Non sappiamo in base a quali prezzi fosse calcolato il valore della merce nel nostro papiro, e in che rapporto essi stessero con i prezzi dati da Plinio un centinaio di anni prima. Poiché però è calcolato solo il valore di quello che rimane dopo il pagamento delle tasse, è inverosimile si trattasse del prezzo al quale quei prodotti erano stati acquistati in India. Presumibilmente si sarà trattato di prezzi considerati come prezzi standard, sui quali orientarsi, tra i commercianti all’ingrosso che operavano ad Alessandria; a questi prezzi si attenevano anche i percettori dei dazi doganali negli indennizzi delle quantità prelevate in eccesso. Un prezzo all’ingrosso, anche se riferito a Roma, ricavato da una qualche tariffa ufficiale può essere anche quello indicato da Plinio[40].
In ogni caso quella di queste linee è sicuramente una merce che doveva essere trattata in grandi quantità, e solo relativamente di lusso: essa rappresenta la parte di gran lunga preponderante del valore complessivo delle merci trasportate dalla Hermapollon, ma il suo prezzo è assai inferiore agli altri indicati nella colonna II. Certamente non si tratta — per rimanere sui prodotti di esportazione dell’India meridionale indicati dalPeriplus Maris Erythraei — di seta, perle, diamanti, gusci di tartaruga, o altre cose del genere [41].
Difficilmente può anche trattarsi dell’altro prodotto importato in grandi quantità dall’India meridionale, il malabathron. I prezzi di questo prodotto sono difficili da valutare[42]. Ma se il malabathron fosse il prodotto di queste linee, dovremmo ammettere che esso rappresentava, con un valore corrispondente ad oltre 2/3 del valore totale del carico e con un peso che con oltre 3.000 talenti non doveva avere una parte meno importante, lo scopo essenziale del viaggio del nostro mercante; e che il pepe avesse invece una parte secondaria.
Se cerchiamo, partendo dal prezzo di 24 dracme per mina, di ricostruire più precisamente la quantità di merce per la quale era calcolato questo valore, 771 talenti o 4.626.000 dracme dovrebbero esser il prezzo di 192.750 mine, ossia di 3.212 talenti e 30 mine. È improbabile però che il prezzo di I.25 finisse davvero con questa linea: rappresentato da un numero tondo di talenti, senza un importo in dracme. Questo importo in dracme doveva essere nella linea che segue. Ora, proprio alla linea I.26 c’è una cifra di 4.632: un numero del genere si riferirà verosimilmente a dracme o a libbre; ma almeno a giudicare dalle sezioni conservate nella colonna II, una quantità in libbre in questa posizione, dopo un prezzo, fa difficoltà. Se si tratta di dracme, è difficile pensare che possa essere qualcosa di diverso dalla parte in dracme del valore indicato alla fine della linea I.25. Si dovrebbe altrimenti presupporre nella prima parte — quella perduta — della linea I.26 l’importo in dracme del valore della linea precedente; quindi l’indicazione dell’oggetto cui si riferirebbe il valore di 4.632 dracme, con l’indicazione del suo peso, che doveva essere di 3 talenti e 13 mine: sempre che le 4.632 dracme non fossero a loro volta precedute da un importo di denaro più grosso, in talenti. Mi sembra difficile che tutta questa serie di indicazioni si trovasse in poco più di mezza linea.
Preferisco pensare che lo scriba, che già nella colonna II mostra un certo gusto per la simmetria che lo porta a lasciare ampi spazi o anche intere linee in bianco, abbia qui lasciato la linea I.26 quasi completamente vuota, per scrivere l’importo in dracme a fine rigo, sotto la relativa cifra in talenti. In questo caso il valore della merce sarebbe di 4.630.632 dracme: corrispondenti, al prezzo di 24 dracme per mina, a 192.943 mine, ossia 3.215 talenti e 43 mine esatte. È una coincidenza singolare che questi 3.215 talenti siano identici alla quantità che io leggo a l. 21. Questo numero di talenti è seguito da un’indicazione in mine costituita da due cifre, delle quali ben visibile è solo un tratto orizzontale, in alto sul rigo, che può essere solo di γ o ς, e che andrebbe molto bene allora per un numero come μγ.
Questa soluzione è assai attraente, ma solleva un problema: essa presuppone che il valore del — come io credo — pepe fosse calcolato sulla quantità di I.21 senza passare attraverso la doppia conversione, da talenti a libbre e poi da libbre in talenti, come per l’avorio. Oppure, che la quantità di I.21 fosse già il risultato della conversione dai ¾ nominali — quelli lasciati al mercante dagli arabarchi — a quelli reali, sui quali calcolare il valore. Ciò è difficile da verificare. Certamente, facendo passare 3.215 talenti e 43 mine per la stessa procedura vista per l’avorio — conversione in libbre al tasso di 97,5 e poi di nuovo in talenti al tasso di 95 — si va a 3.300 talenti e c. 20,5 mine: un numero diverso a quello che io leggerei alla l. 20. D’altra parte, se non si tratta del risultato di una conversione che passa attraverso le libbre, la differenza tra le cifre di I.20 e I.21 è difficile da spiegare: essa rappresenta oltre il 2,8 % della prima quantità, per un valore monetario intorno ai 24 talenti. Che questa differenza fosse la parte presa degli arabarchi come per l’avorio è improbabile: si è visto che queste quantità si giustificano solo come arrotondamento per prodotti difficilmente divisibili con esattezza. Essa non dovrebbe giocare alcun ruolo per un prodotto misurato semplicemente secondo il peso. Con un valore di 144.000 dracme essa avrebbe — una volta stabilito che in questi calcoli una logica di percentuali non gioca alcun ruolo — un valore esorbitante rispetto alle 1.175 e 1.592 ½ dracme rispettivamente di avorio ‘sano’ e di schidai.
Per quel poco che si può vedere dalle linee — ancora tutte da leggere, ma comunque senza paralleli nel papiro — comprese tra le due grosse quantità di talenti e l’alto importo di denaro di oltre 771 talenti, questa parte doveva seguire uno schema diverso da quello, ben conservato, che vediamo nelle due sezioni dell’avorio alla colonna II. E mi sembra difficile riconoscerci le stesse procedure. Non sappiamo insomma come si procedesse per questo prodotto, quali conversioni, e quali eventuali operazioni contabili supplementari entrassero in gioco.
Ci si dovrà contentare allora di dire che si trattava verosimilmente di una quantità di pepe intorno ai 3.200–3.300 talenti, per un valore, al prezzo di 24 dracme per mina, di oltre 771 talenti: verosimilmente di 771 talenti e 4.632 dracme. La quantità originaria di pepe sarà stata intorno ai 4.400 talenti, e la sua tetarte intorno ai 1.100 talenti.
Nella colonna I c’era visibilmente ancora qualcos’altro. Del resto i 1.151 talenti e 5.852 dracme del totale di II.57 lasciano, detratti i valori della stessa colonna II, 1.021 talenti e 694,5 dracme. Di questo importo restano, dopo l’ulteriore detrazione dei 771 talenti e 4.632 dracme del prodotto di I.20 ss., ancora 249 talenti e 2.062,5 dracme. Questo valore non è affatto basso: esso è di poco inferiore al doppio della somma di tutti i prodotti della colonna II. Questo importo di denaro si dovrà raggiungere con le linee I.15–19, e forse le linee I.27 o I.28 ss., se le merci ancora mancanti erano due.
Un importo di denaro di 220 (o comunque almeno 200) + x talenti è registrato in I.19: si tratta del valore della merce delle linee precedenti. La quantità di questa merce è difficile da definire: lo ὁλκ(ῆϲ) di I.17 porta poco lontano poiché delle quantità resta solo un’indicazione di 23 ¼ o forse 20 ¼ mine. La linea successiva è più promettente, poiché vi si legge un’indicazione di migliaia, direi 1.200, seguita da una breve lacuna, e poi da una quantità in mine. Per l’immediata vicinanza con una quantità in mine, questa cifra in migliaia sembra essere riferita ad un peso in talenti piuttosto che ad un importo di denaro, in dracme. Un valore di 220 (o 200) talenti diviso per una quantità di 1.200 talenti dà un prezzo di 18 1/3 (o 16 2/3) dracme per mina. Se tutti i 249 talenti e 2.062,5 dracme che mancano per arrivare al totale di II.57 fossero in questa sezione, una quantità di 1.200 talenti darebbe un prezzo di c. 20,78 dracme per mina. Un dato del genere fa pensare ad un prezzo, in sé plausibilissimo, di 20 dracme per mina, che di riflesso porterebbe a calcolare una quantità esatta di 1.241 talenti e 43 ¼ mine. Una lettura γ δ sarebbe di fatto possibile per le cifre subito dopo la lacuna di I.18. Ma che l’intero valore di 249 talenti e 2.062,5 dracme sia da cercare in questa sezione è solo una possibilità: neppure la più probabile, a giudicare da quello che si vede sul papiro.
In ogni caso questi dati, per quanto approssimativi e basati su cifre incomplete, sono sufficienti a dare — se il valore di I.19 si riferisce alla quantità di I.18 — un ordine di grandezza per il nostro prezzo: intorno alle 16–20 dracme per mina, vicino dunque a quello del pepe. Si trattava forse di una qualità di pepe meno costosa, o abbiamo qui il malabathron che secondo il Periplus Maris Erythraei era, insieme al pepe, il motivo principale di questi viaggi verso l’India meridionale[43]? Il prezzo è un po’ basso, di poco inferiore a quello del (?) pepe, mentre per il malabathron ci aspetteremmo un prezzo più elevato. Ma P.Oxy. LIV 3731 mostra che all’inizio del IV secolo le due droghe potevano avere lo stesso prezzo[44].
Infine ci sono le ultime linee della colonna, sotto la I.25 e verosimilmente I.26, che potevano essere — e anzi probabilmente erano — qualcuna in più delle due che vediamo adesso: già la colonna II ha una linea al di sotto dell’ultima linea conservata della colonna I. D’altra parte con la colonna II il conto finisce, e la colonna I poteva aver utilizzato parte del margine di 4,5 cm che si vede nella parte bassa del foglio. Si trattava qui di un una nuova merce, o si continuavano a dare indicazioni relative a quella delle linee precedenti?
Totali e tetartai di queste due o tre merci mal conservate della colonna I dovevano essere indicati nella parte alta della colonna, sopra le stesse indicazioni relative a nardo ed avorio. Solo in questo modo si mantiene per la prima parte del conto, quella con totali e tetartai, la stessa successione dei prodotti della seconda parte, con il calcolo del valore dei rimanenti ¾. Questo parallelismo tra le due parti, in sé verosimile, è di fatto constatabile là dove entrambe le sezioni permettano la verifica.
All’inizio della colonna I sono attualmente conservate le parti finali di tre linee, con quantità rispettivamente di 59 mine, 14 ¾ mine, e 58 mine. La soluzione più immediata sarebbe considerare tre registrazioni da una linea ciascuna, come quella del nardo di I.4: le 59 mine di I.1 sarebbero la parte finale di una tetarte, ricavata da una quantità totale che doveva finire con 56 mine; i ¾ rimasti al mercante sarebbero stati rappresentati da una quantità che terminava con 57 mine. Le 14 ¾ mine di I.2 potrebbero essere la tetarte di un totale che finiva con 59 mine, i cui ¾ sarebbero stati rappresentati da una quantità che terminava con 44 ¼ mine. E le 58 mine di I.3 sarebbero la tetarte di una quantità che terminava con 52 mine, i cui ¾ sarebbero terminati con 54 mine.
Tutto ciò è assai difficile da verificare. Nessuna di queste cifre è leggibile tra quelle che si vedono — per altro spesso incerte — nella parte inferiore della colonna; con l’eccezione, probabilmente, delle 44 ¼ mine di I.27. E tuttavia, se questa cifra stesse in relazione con quella di I.2, essa costringerebbe a postulare una successione diversa dei vari prodotti tra la prima parte della colonna, con quantità originarie e tetartai, e la seconda, con i ¾ rimasti al mercante.
Delle relazioni sono se mai più probabili con la sezione meglio conservata della colonna, quella che verosimilmente riguarda il pepe: se le 58 mine di I.3 sono la parte di una tetarte, esse presupporrebbero — nell’ambito dei numeri immaginabili per la quantità del pepe — una quantità a I.20 di 3.308 talenti e 54 mine: dove di fatto una lettura ᾿Γτ̣η̣ è quella che mi sembra la più probabile; e quantità di 4.411 talenti e 52 mine per il totale e di 1.102 talenti e 58 mine per la tetarte in I.3.
Alternativamente, si può osservare che le 14 ¾ mine di I.2 sono uguali a ¼ delle 59 di I.1. Queste cifre potrebbero bene allora essere i resti di due quantità, riferite la prima alla quantità totale di un prodotto, la seconda alla sua tetarte. Se si trattasse del pepe, si dovrebbe pensare a 3.315 talenti per I.20 — lettura che in effetti è possibile in luogo del ᾿Γτ̣η̣ che io ho preferito, vedi sopra la n. ad l. —, per un totale di 4.420 talenti, e una tetarte di 1.105 talenti. D’altra parte, se la quantità totale finisce con 59 mine, la quantità che indica i suoi ¾ dovrà terminare con 44 ¼ mine. Questi dati sarebbero da integrare rispettivamente alle ll. 1, 2 e 20. Ho già rilevato che una quantità di 44 ¼ (se non si tratta di 42 ¼ o 41 ¼ mine) si trova a l. 27: non so però se essa sia in relazione con le cifre che ho ricostruito finora — una ripetizione del totale? —, o se si tratti di tutt’altra cosa. E, secondo quella che è la successione dei prodotti nella parte in cui se ne calcola il valore, all’inizio del conto dovremmo avere totale e tetarte del prodotto o dei prodotti di I.14–19. Il pepe dovrebbe invece occupare solo la seconda o la terza posizione. Ipotizzare una o due linee perdute in alto sulla colonna I non aiuta, perché comunque in esse dovrebbe trovare posto un’intestazione con indicazione del contenuto del conto.
Le soluzioni possibili sono, si vede, più d’una, e tutte molto incerte. È bene che a questo punto anch’io rinunci ad andare avanti.
Riepiloghiamo comunque le quantità delle merci trasportate, iniziando dai dati più sicuri per venire poi a quelli più incerti e approssimativi:
167 zanne di elefante per un peso di 105 talenti e 13 mine: si tratta di c. 3.314 kg;
17 talenti e 33 mine di zanne incrinate: c. 553 kg;
intorno ai 4.410 talenti verosimilmente di pepe: c. 138.915 kg;
intorno ai 1.200 talenti per il prodotto di I.18: 37.800 kg;
80 kistai di nardo, il cui significato è più difficile da quantificare: pensando alla kiste come ad un contenitore capace di contenere una o poche decine di litri[45], si sarà trattato di una quantità dell’ordine di grandezza delle centinaia di kg, ed al massimo di una o poche tonnellate.
Anche l’eventuale terzo prodotto della colonna I avrà rappresentato un peso trascurabile, non in grado di modificare la stima approssimativa che qui è possibile dare. In tutto si arriva a poco più di 180 tonnellate per l’intero carico, e poco più di 130 tonnellate per la parte del mercante: si può pensare a qualcosa come 8.000–9.000 artabai[46] per l’intero carico e 6.000–7.000 per la parte del mercante.
Navi di dimensioni maggiori, fino al doppio, erano adibite in età tolemaica al trasporto del grano sul Nilo: per una serie di kerkouroi — imbarcazioni a remi — P.Tebt. III.2 856 (Arsinoite c. 171 a.C.) dà portate di 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 16.000, 18.000 artabai. [47] Ci possiamo immaginare un’imbarcazione lunga sui 20–30 metri, con un rapporto larghezza/lunghezza di 1 : 3[48]. Navi di questo genere viaggiavano certamente anche per mare su tratte lunghe[49], ma appartenevano piuttosto alla classe di dimensioni medie o medio-piccole: la misura preferita dal governo romano per il trasporto di grano fino a Roma era non inferiore a 340 tonnellate [50].
Un’altra cosa che dà da pensare è il nome di questa nave: il nome di persona Hermapollon ha più di un centinaio di attestazioni in una cinquantina di documenti, distribuiti tra il II e il VII secolo. Quel che è più interessante è il fatto che essi provengono quasi tutti — prevedibilmente — dall’Ermopolite o dall’Antinoite. In pochi casi la provenienza è ignota. Pochissimi documenti hanno provenienze diverse: BGU IX 1898.230, dopo il 172 da Theadelphia; P.Oxy. XVI 1949.1, del 481, viene dal confinante Ossirinchite; in O.Ont.Mus. II 287 III 14, del II secolo da Tentyra, un Hermapollon è in una lista di persone; in O.Claud. II 374 infine, del II secolo, Hermapollon è una persona inviata insieme ad un soldato, ma non sappiamo di dove fosse. Si tratta evidentemente di un nome tipicamente Ermopolita[51]. Come nome di nave, neppure di Hermes sono note molte attestazioni nel mondo antico[52]: nella lista di battelli fluviali del IV secolo[53] P.Oxy. XXIV 2415.27–28, c’è una nave Hermes, capace di trasportare 3.100 artabai. Anche qui siamo sul Nilo, assai vicino all’Ermopolite.
Ancora, se il testo sul verso del papiro è stato scritto ad Alessandria dopo che tutto era stato scaricato ed era stata fatta la tetartologia, perché mai si dovrebbero connotare le merci secondo il nome della nave con la quale avevano viaggiato per mare, e non piuttosto secondo quella sulla quale erano arrivate nella stessa Alessandria? Il mercante che prende il prestito del recto non è un comandante o un armatore, ma solo un uomo di affari: egli non ha alcun legame particolare con la nave sulla quale — forse insieme ad altri mercanti che come lui facevano affari con l’India — ha viaggiato da Muziris, più di quanto egli non possa averne con il battello fluviale che lo porta da Copto ad Alessandria. Per entrambe egli deve pagare un nolo. E per chi è in Alessandria quelle merci sono il carico del battello fluviale sul quale esse sono arrivate lì, non di una nave che ha attraversato il mare Eritreo.
Ma c’è un problema più grosso: ἐκπλέω significa nei papiri quanto nella letteratura “partire per nave”, non “arrivare”, e neppure “viaggiare” o “navigare”. Per rimediare si è cercato di intendere ἐκπεπλευκότων passando dal senso di “partite” a quello di “esportate” (scil. dall’India), e di qui poi a quello di “importate” (in Egitto)[54]. La differenza tra esportare e importare, come tra partire e arrivare, è soggettiva e dipende da dove si trova chi parla, o dalla posizione nella quale egli si mette o si vede in relazione ad una determinata località. Così nello gnomon dello idios logos, BGU V 1210.162, 165, 168 e 171 (Arsinoite c. 150), ἐκπλέω e ἔκπλουϲ indicano rispettivamente il partire e la partenza (l’editore traduce “ausfahren” e “Ausfahrt”) ovviamente dall’Egitto, dove è stato scritto il documento e al quale esso si riferisce. Allo stesso modo lo ἐξάγειν degli stessi paragrafi, alle ll. 164 e 166, indica l’esportare dall’Egitto verso un altro paese e non da un altro paese verso l’Egitto. In P.Cairo Zen. I 59019.1–2 (Philadelphia/Alessandria? 258–256 a.C., P.Lugd.Bat. XXIA p. 174), lo scrivente usa μετὰ <τό ϲε> ἐκπλεῦϲαι εἰϲήγαγον τ̣[ὸν] | [θερα]πεύοντα τοὺϲ δορκαδέουϲ, per riferirsi alla partenza del destinatario dalla località dalla quale egli scrive. In P.Lond. VII 1979.5–6 (Philadelphia/Alessandria prima del 252 a.C.) καὶ ἐκπλέον-|τεϲ̣ κατέλιπον τύλαϲ, il mittente, da Alessandria, parla del padre di Zenone partito dalla stessa Alessandria per Cauno. Lo scrivente di O.Narm. 114.9–10 (II/III) si riferisce con ἐκπλέω ad una navigazione che egli intraprenderà partendo dal luogo in cui egli si trova mentre scrive. La Aurelia Marciana di P.Oxy. X 1271 = CEL I 213 (246, P. J. Sijpesteijn, Small Notes on Bilingual Papyri, ZPE 42 [1981] 108 s.) intende partire per nave (βούλομαι κύριε ἐκλπεῦϲαι a l. 3) da Alessandria, e chiede per questo al prefetto d’Egitto di ordinare al comandate del Faro di autorizzare la sua partenza. La Hikane di O.Ber. II 129.9 (I) infine chiede al figlio di partire, evidentemente dalla località in cui egli si trova, Berenice[55].
È difficile allora capire come un mercante greco-egizio che ha acquistato delle merci in India e le ha trasportate in Egitto, ne potesse parlare come di qualcosa che egli ha esportato o che è partito (scil. dall’India, non menzionata), invece che importato o arrivato in Egitto. Se si evita di interpretare liberamente il verbo ἐκπεπλευκότων in “esportate” o “importate”, e ci si tiene invece vicini al greco traducendo “partite per nave”, ci si rende meglio conto di quanto sia difficile pensare che una costruzione come “i carichi partiti sulla nave Hermapollon”, usata da persone che si trovavano in Egitto e senza alcun accenno al luogo di partenza, potesse fare riferimento al viaggio dall’India alla costa egiziana.
In qualche modo più correttamente gli editori Harrauer e Sijpesteijn[56] intendevano lo ἐκπεπλευκότων nel senso che le merci erano state caricate e spedite via con la nave; anche se, ritenendo il testo scritto ad Alessandria, pensavano che la nave fosse partita da Alessandria verso Roma. Questa interpretazione è logica, coerente, e linguisticamente corretta, anche se alla fine non è quella giusta.
Che interesse avrebbe il mercante a preoccuparsi del valore di un carico partito per Roma? Il contratto del recto pone in Alessandria, con il pagamento della tetarte, la conclusione della transazione. E soprattutto, in II.55 s. si parla delle tre parti dei carichi partiti — per intero — con la nave Hermapollon; non delle tre parti che, di un carico originario ormai diviso, sarebbero partite sulla Hermapollon. Insomma, sembra che tutti i 4/4 del carico viaggiassero su questa nave.
Se non si vuole pensare che i ¾ del carico partissero con la tetarte per Roma, si devono riconsiderare il momento e il luogo in cui è stato scritto il verso del papiro. Al momento in cui si scrive è stata già fatta la tetartologia e la merce è stata divisa nelle due parti previste. Le conversioni e ancor più gli arrotondamenti riscattati in denaro, insieme all’uso degli aoristi passivi ἀρθέντων e ἀρθειϲῶν mostrano che la divisione è stata fatta davvero, e che non si tratta solo di una previsione fatta dal mercante.
D’altra parte, dal recto risulta chiaramente che i magazzini della tetarte e il pagamento di questa tassa, che segna anche la fine dell’operazione commerciale, sono da collocare ad Alessandria. Lo stesso recto però dice che magazzini fiscali si trovavano anche a Copto, un centro importante per l’amministrazione dell’arabarchia[57]. Dal nostro conto sappiamo che, oltre alla tetarte e al suo arrotondamento, niente è stato tolto in natura dal carico. Dobbiamo allora concludere che, se anche gli arabarchi o agenti dell’arabarchia di Copto dovevano riscuotere delle tasse doganali, queste non potevano essere che in denaro. Rimane la questione di quale fosse la funzione di questi magazzini fiscali in Copto, l’emporio per le merci provenienti dall’India e dall’oriente; e perché mai anche le merci del nostro papiro dovessero passare attraverso questi magazzini. Nella stessa Copto e negli stessi magazzini fiscali il carico avrebbe dovuto essere controllato e registrato anche dagli agenti del creditore incaricati di prendere le merci sotto la loro disposizione e sigillo: recto 4–6, καὶ ποι|[ήϲω ὑ]π̣ὸ τὴν ϲὴν ἢ τῶν ϲῶν ἐπιτρόπων ἢ τοῦ παρόντοϲ αὐτῶν | [ἐξουϲία]ν (cfr. l. 9) καὶ ϲφραγεῖδα.
Evidentemente in questi magazzini dovevano essere controllate, pesate e registrate le merci che arrivavano nella valle del Nilo, prima di poter proseguire per Alessandria[58]. Nell’ambito di queste operazioni doveva essere definita anche la tetarte[59]. Il controllo e la registrazione delle merci a Copto, prima dell’imbarco sui battelli fluviali, era misura necessaria: lì le merci entravano davvero nell’impero e il viaggio sul Nilo era impossibile da controllare, con una quantità di porti ed approdi dove una nave avrebbe potuto fermarsi e scaricare parte del carico [60].
D’altra parte l’amministrazione non aveva alcun interesse a trattenere quantità di merci riscosse a titolo di tetarte nella stessa Copto. Queste merci non erano destinate al mercato interno egiziano ed avrebbero comunque dovuto essere trasportate ad Alessandria. La procedura più razionale era allora di lasciare al mercante l’onere di organizzare ed effettuare il trasporto sul Nilo dell’intero carico: anche della tetarte, ormai già definita e sigillata separatamente dai rimanenti ¾. Solo ad Alessandria, nei magazzini della tetarte, le tasse doganali sarebbero state effettivamente riscosse, in natura[61].
È in questa fase che io collocherei la redazione del nostro conto: dopo la pesatura e registrazione del carico con il calcolo della tetarte, e dopo che le merci erano partite sulla Hermapollon; ma comunque prima che la parte della tetarte fosse separata definitivamente dal resto, poiché la Hermapollon trasporta ancora tutto l’intero carico. Il conto poteva essere stato redatto o dal mercante stesso, che intendeva in questo modo valutare le proprie merci, o da uno degli agenti del creditore che a Copto dovevano registrare il carico. Esso comunque è anteriore all’arrivo della nave ad Alessandria e rispecchia un momento precedente ad un eventuale passaggio o vendita del carico al creditore, come previsto dal contratto sul recto in caso di mancata o ritardata restituzione del prestito. Il conto poteva essere scritto nella stessa Copto, o a bordo della Hermapollon. Dunque non molto dopo e non molto distante dalla scrittura del contratto sul recto, redatto all’arrivo del carico in un porto sul Mar Rosso. Questo — per quanto anche il ritrovamento di un documento scritto ad Alessandria non sarebbe in sé affatto un problema — renderebbe più ovvia la sua conservazione fino a noi. E i due testi, scritti sulle due facce di uno stesso foglio, avrebbero una connessione più intima: il mercante o, come io credo piuttosto, uno degli agenti del creditore che si trovavano a Copto, avrebbe registrato sul retro della sua copia del contratto il valore delle merci oggetto e garanzia del contratto stesso.
Il fatto che il nostro papiro mostri una riscossione delle imposte doganali duplice soltanto nel procedimento, e non nel numero delle imposte — tetarte e ‘parte degli arabarchi’ —, non significa che altre tasse da pagare a Berenice o anche a Copto non esistessero. In ogni caso esse non hanno lasciato tracce nel nostro documento, e se c’erano dovevano essere in denaro.
Quanto alla possibilità che anche in uscita fossero riscosse imposte doganali, eventualmente ancora del 25 %, il nostro papiro non può dire niente, né in positivo né in negativo. Esso mostra soltanto che la tetarte di importazione era riscossa in Alessandria; ed esso mostra, è vero, una sola tetarte e in generale una sola imposta doganale. Ma con il suo pagamento e con la vendita del carico nella stessa Alessandria il mercante considerava conclusa la sua operazione commerciale. Le merci che egli aveva importato dall’India sarebbero passate ad altri mercanti: direttamente, o per il tramite del creditore o di altri intermediari. Su questi nuovi mercanti che avrebbero esportato le merci verso Roma o altrove, sarebbero ricaduti anche gli eventuali nuovi oneri fiscali. Ma la cosa non interessava più gli uomini d’affari che hanno scritto o fatto scrivere il papiro.
- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -
Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik |
Federico Morelli |
* Devo il mio interesse per il papiro di Muziris a Federico De Romanis, che durante un suo soggiorno a Vienna ha richiamato la mia attenzione sulle numerose difficoltà ancora aperte di questo testo. Le discussioni con De Romanis, insieme alla lettura dei suoi lavori, mi sono state fondamentali per la prima comprensione di questi difficili documenti. Dopo la conclusione di questo articolo ho potuto ridiscutere del papiro con lo stesso De Romanis durante un suo secondo soggiorno a Vienna, e leggere il suo lavoro ancora inedito Playing sudoku on the verso of the ‘Muziris papyrus’: Pepper, malabathron and tortoise shell in the cargo of the Hermapollon (di prossima pubblicazione nel Journal of Ancient Indian History), nel quale egli, tra le altre cose, arriva indipendentemente da me alla corretta lettura delle ll. 25–26 della col. I verso. La revisione del papiro è un prodotto secondario del progetto P 23408 finanziato dal Wissenschaftsfonds austriaco (Austrian Science Fund, FWF).
[1] H. Harrauer, P. J. Sijpesteijn, Ein neues Dokument zu Roms Indienhandel. P.Vindob. G 40822, Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 122 (1985) 124–155.
[2] Per primi da G. Thür, Hypotheken-Urkunde eines Seedarlehens für eine Reise nach Muziris und Apographe für die Tetarte in Alexandria, Tyche 2 (1987) 229–245, e L. Casson, P.Vindob. G 40822 and the Shipping of Goods from India, BASP 23 (1986) 73–79; New Light on Maritime Loans: P.Vindob. G 40822, ZPE 84 (1990) 195–206. Si tratta di contributi notevolissimi, ricchi di osservazioni acute e fondamentali per la comprensione del testo. Essi però, come buona parte della letteratura su questo papiro, si fondano sulle letture dell’ ed. pr.; quando sono state proposte nuove letture, esse sono basate sulla riproduzione pubblicata con l’ed. pr., mentre solo occasionalmente e per lo più di seconda mano esse sono state verificate sull’originale. Si vedrà invece che un riesame sistematico e in dettaglio dell’originale permette di fare progressi non irrilevanti. In tempi recenti è stata resa accessibile in internet una riproduzione di buona qualità (http://aleph.onb.ac.at/F/?func=find-c&ccl_term=WID% 3DRZ00001642&local_base=ONB08), che certamente faciliterà ulteriori progressi nella lettura. E da far presente comunque che il papiro sul quale si trovano i due documenti è molto sottile, e lascia in moltissimi punti trasparire tratti della scrittura dell’altra faccia. Ciò produce spesso impressioni ingannevoli che possono essere adeguatamente valutate soltanto — e neanche sempre facilmente — con originale e microscopio.
[3] Più alcune note minime di dettaglio: al centro del margine superiore, subito sopra ρο di ἐπιτρόπων, si vede un segno che non so spiegare, ma che comunque segnalo; a l. 7 leggo ποτάμι̣ον invece del ποταμόν dell’ed. pr.: visibile è un resto della parte superiore dello ι, anche se probabilmente la lettera è stata inserita in un secondo momento tra μ e o. Che si dovesse intendere ποτάμ<ι>ον era per altro già stato proposto da L. Koenen in Casson, New Light (n. 2) 197. All’inizio di l. 8 si vede un resto della parte inferiore di ξ, dunque si deve leggere Ἀλε]ξ̣ανδρείᾳ. A l. 11 l’integrazione φορέτρων di Thür, Hypotheken-Urkunde (n. 2) 230 invece del φο[ρέτρου] dell’ed. pr. è sicura: il tratto verticale del ν finale è visibile sul bordo della lacuna, e propriamente si deve leggere φο-|[ρέτρω]ν̣. Alla fine di l. 17 ci sono, più o meno conservate, tutte le lettere: dunque προκε̣ι̣-. A l. 25 il papiro ha ἐνλείμματοϲ con due μ e come sarebbe più corretto, e non l’ ἐνλείματοϲ di ed. pr. e riedizioni successive.
[4] Semplice o, come mi suggerisce Nikolaos Gonis, παραδώϲω o altro composto.
[5] Ancora, per quanto questa non sia una argomentazione decisiva, in una costruzione in cui si dica di dare qualcosa πρόϲ + nome di azione (ἐπίθεϲιν), mi aspetto che questo qualcosa sia l’oggetto dell’azione stessa, piuttosto che il pagamento per essa. Si noti anche l’assenza dell’articolo. Per il senso da dare a ἐπίθεϲιϲ, H. Cuvigny in P.Worp pp. 321–322.
[6] La lettura è stata fatta da De Romanis sull’originale nel febbraio 2011, ed è da me confermata. Essa elimina il difficile ποταμίταιϲ dell’ ed. pr.: i potamitai non lavorano sui battelli fluviali, bensì alla costruzione e manutenzione di dighe, canali e altre opere idrauliche. Il pagamento di un naulon a queste persone sarebbe inspiegabile.
[7] Thür, Hypotheken-Urkunde (n. 2) 234 n. 11.
[8] Commercio, metrologia, fiscalità. Su P.Vindob. G 40.822 verso , MEFRA 110 (1998) 20. Vedi anche più avanti, n. 16.
[9] In proposito si noterà ancora che Thür dà nel suo ragionamento come scontato qualcosa che in realtà il testo non dice affatto, e cioè che il creditore sarebbe pronto a coprire queste spese per la parte finale del viaggio: ad esempio Hypotheken-Urkunde (n. 2) 240, “Damit der Transport nicht stockt, ist vorgesehen, daß der Kreditgeber unterwegs auch jene Auslagen vorstrecken läßt, welche die möglicherweise erschöpfte Finanzkraft des Emporos übersteigen.” Questo intervento del creditore risulterebbe solo implicitamente dal fatto che le spese (scil. da lui sostenute: ma questo il papiro non lo dice) sarebbero il motivo per cui egli può disporre del carico. E il testo tratterebbe delle conseguenze di ulteriori finanziamenti senza neppure menzionare la possibilità che tali finanziamenti fossero accordati. Che ciò fosse detto in una parte perduta del contratto è da escludere: proprio la parte relativa alle fasi che eventualmente avrebbero dovuto beneficiare di questo sostegno finanziario è l’unica — non a caso, si vedrà — conservata. Che un simile intervento potesse essere considerato dalle parti come scontato, tanto che non valesse neppure la pena di menzionarlo, mi pare ancora più inverosimile. Neppure il fatto che questa possibilità potesse essere prevista nel Seedarlehen del quale, secondo la costruzione di Thür, il nostro dovrebbe essere una Hypotheken-Urkunde separata, giustificherebbe il silenzio su un punto così importante.
[10] R. Kühner, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, Zweiter Teil, Satzlehre. Dritte Aufl. besorgt von B. Gerth, Erster Band, Hannover und Leipzig 1898, 438–440.
[11] E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, II.2.1, Berlin, Leipzig 1933, 284 s.
[12] Ad esempio P.Heid. VI 383.13–14 (Arsinoite 209 a.C.), [ἐμβαλο]ῦ̣μ̣αι εἰϲ τὸ πλοῖον̣ | [ἰδίοιϲ ἀν]α̣λ̣ώ̣μαϲιν; P.Dion. 16.24–25 (Akoris 109 a.C.), καθε̣ϲ̣τ̣α̣μ̣έ̣[ναϲ] | ἐπὶ τὸν κατὰ τὴν Ἀκώριοϲ ὅρμον τοῖϲ ἰδίοιϲ ἀναλώμαϲι; cfr. anche P.Dion. 17.24–25 e 20.20–21 (entrambi Akoris, rispettivamente 108 e 105 a.C.).
[13] Mayser, Grammatik (n. 11) II.2.1, 280 riporta in primo luogo tra le “in formelhaft wiederkehrenden adverbialen Wendungen” proprio una serie di esempi per τοῖϲ ἰδίοιϲ ἀνηλώμαϲι e simili. Un bel parallelo è ad esempio in P.Oxy. XXXVI 2795.18–21 (250), μετρίτω (sic) ὁ με-|μιϲθωμένοϲ εἰϲ δημόϲιον θη-|ϲαυρὸν εἰδίαιϲ (sic) ἑαυτοῦ δαπάναιϲ καὶ ἀν-|αλώμαϲι πᾶϲι.
[14] Propriamente mi aspetterei qui la menzione di un naulon di questo ploion — come subito dopo per i noli fluviali —, piuttosto che quella del ploion tout court. Mi aspetterei anche che questo ploion fosse in qualche modo qualificato come marino, θαλάϲϲιον, allo stesso modo in cui i noli sono detti fluviali.
[15] Così invece Thür, Hypotheken-Urkunde (n. 2) 231, che usando la preposizione für tanto per il dativo causale ταῖϲ — δαπάναιϲ πάϲαιϲ quanto per i genitivi che da questo dativo dipenderebbero eliminava la differenza di livello tra i vari membri della frase: “für alle Ausgaben für das Seeschiff von jetzt an bis zur Erhebung der Tetarte und für Frachtlöhne durch das Wüstengebirge, etc.” D’altra parte lo stesso Thür manifesta il suo disagio di fronte all’incongruenza logica e sintattica di questa frase nel diffuso e articolato commentario: 234 n. 12: “Da ein Emporos nicht Schiffseigentümer (Naukleros) ist (...), stehen an erster Stelle die sicher beträchtlichen Kosten für die Passage und Fracht nach und von Indien.” E soprattutto n. 13: “Streng nach der Wortstellung bezieht sich die Zeitangabe nur auf die Seereise, wofür gewiß die höchsten Auslagen anfallen können. Jedoch sind mit Sicherheit auch die später genannten Auslagen des Kreditgebers für den Transport der Waren nach Alexandreia mit eingeschlossen. Liegt der Zeitpunkt „von jetzt an“ bereits vor der Seefahrt, können folglich auch Auslagen für die Hinreise gemeint sein.” etc. Ancora 235 n. 14: “... Über eine Fracht nach Indien fehlen im erhaltenen Fragment jegliche Angaben” etc.
[16] In questo senso le integrazioni [τοῦ λοι]π̣οῦ di Casson, P.Vindob. G 40822 (n. 2) 74, e [τοῦ (oppure ἐκ) δανε]ί̣ου di De Romanis, Commercio (n. 8) 20–21, sarebbero, ciascuna per motivi diversi, più logiche e soprattutto linguisticamente accettabili. Anzi, l’integrazione di De Romanis è l’unica che, non ‘nascondendo’ il prestito che è il vero motivo per cui il creditore ha dei diritti sul carico, è anche logicamente sostenibile in connessione con un dativo di causa.
[17] In particolare per i contratti di affitto di terreno vedi D. Hennig, Die Arbeitsverpflichtungen der Pächter in Landpachtverträgen aus dem Faijum, ZPE 9 (1972) 117–118.
[18] Stranezza enigmatica rilevata già da De Romanis, Commercio (n. 8) 21, che pur seguendo l’interpretazione di Thür sul luogo di scrittura del papiro, propone di integrare [τοῦ δανε]ί̣ου o [ἐκ δανε]ί̣ου.
[19]
Lo stesso Thür, che a p. 232 n. 12 aveva considerato quelle per il ploion (marino) come le principali tra le δαπάναι πᾶϲαι a causa delle
quali il creditore può disporre del carico, sembra invece escluderle quando a p. 240 scrive che tutte le spese devono essere sostenute dall’
emporos
, e circoscrive l’intervento del creditore a quelle spese che alla fine del viaggio “die möglicherweise erschöpfte Finanzkraft des Emporos
übersteigen”. Analogamente e più diffusamente a p. 234 n. 11: “Mit dem Dativ δαπάναιϲ (...) wird der Zweck des in Z. 9 eingeräumten
Verfügungsrechts bezeichnet: Grundsätzlich hatte der Emporos die Transportkosten für seine Waren selbst zu bestreiten (...). Doch konnte
er aus Indien ohne das hiefür nötige Bargeld zurückkommen. (...) Also konnte der Fall eintreten, daß der Kreditgeber oder seine Leute für den Emporos Transportkosten auslegten.”
[20] Casson, P.Vindob. G 40822 (n. 2) 78, e New Light (n. 2) 203–205. Tra le più notevoli differenze menziono l’interpretazione che Casson dava nel primo articolo, in BASP, della transazione come un contratto che avrebbe trasformato il prestito marittimo, secondo lui concluso a Muziris, in un normale prestito in conseguenza delle mutate condizioni e del diminuito rischio; o più tardi, nell’articolo della ZPE, come un contratto che a garanzia del creditore fissava i doveri del debitore per la parte finale dell’operazione commerciale. A proposito dell’integrazione di Casson [τοῦ λοι]π̣οῦ, G. Thür, Zum Seedarlehen κατὰ Μουζεῖριν, Tyche 3 (1988) 232, ritiene che l’eliminazione del ploion dell’ed. pr. non sia sufficiente a rimuovere la stesura del contratto da Alessandria. Semplicemente, il debitore sarebbe stato dipendente dal creditore solo per i costi del trasporto terrestre e fluviale, e non — per altro auffälligerweise, come egli stesso ammette — per quelli del ploion marittimo. Ma lo spostamento del νῦν da Alessandria ad un’altra località deriva non dall’eliminazione in sé del ploion (marino), quanto dal fatto che le spese elencate subito dopo in ordine cronologico, e cioè i costi di trasporto per il deserto, i noli fluviali, e infine le altre spese varie ed eventuali, sono l’esplicitazione delle δαπάναι πᾶϲαι ἀπὸ τοῦ νῦν μέχρι τεταρτολογίαϲ: altre spese, per quanto certo coperte con il δάνειον κατὰ Μουζεῖριν, qui mancano e devono allora collocarsi prima del νῦν.
[21] Né i ναῦλα ποτάμια possono sostenere l’idea che i viaggi sul Nilo presi in considerazione fossero due, uno all’andata e uno al ritorno: il plurale ναῦλα può essere usato in senso generico, indipendentemente dal fatto che si trattasse di uno solo o di più noli: cfr. ad esempio P.Gen. I 14.8 (? VI/VII), τὰ ναῦλα τοῦ μικροῦ πλοιαρίου λαβεῖν παρὰ τοῦ ναύτου; P.Oxy. XXXIV 2732.9 (VI?) ἐγὼ καὶ \τὰ/ ναῦλα τοῦ πλοίου παρέχω; P.Strasb. VI 558.2–4 (? c. 300) καταπλόου | ἕωϲ Ϲχεδίαϲ | ναῦλα πλύου (l. πλοίου); SB XIV 11918.3–4 = P.Apoll.Anô 107 (VII) ἐρχομένου τοῦ πλοίου | ὃ λαμβάνει τὰ ναῦλα; T.Varie 3.19 (Ermopolite 621 o 636, R. S. Bagnall, K. A. Worp CSBE2 296), δεχόμενοϲ (l. δεχομένου ) <ἐμοῦ> τὰ προκείμενα ναῦλα ἐκ πλήρο<υ>ϲ. Lo stesso vale per i φόρετρα: cito solo P.Col. III 8.3–4 (Philadelphia 257 a.C.), dove il termine è usato in relazione ad un battello, ὧν καταβεβλήκαμεν παντὸϲ | [τοῦ πλο]ί̣ο̣υ φόρετρα διὰ τὸ μὴ εἰπεῖν ἡμῖν ἐπὶ τοῦ πλοίου ὅτι κτλ.
[22] Tutto ciò elimina, ovviamente, la necessità di considerare il nostro papiro come una Hypotheken-Urkunde stesa — contro la consuetudine — separatamente dal Seedarlehen vero e proprio. Buoni argomenti contro questa interpretazione sono già in Casson, New Light (n. 2) 203. Lo stesso Thür che proponeva questa interpretazione, ammetteva a p. 242 che le hypothekai sono normalmente fissate nel contratto di prestito stesso, e che paralleli per una “selbständige Hypothekenurkunde” mancano del tutto.
[23] F. De Romanis, Cassia, cinnamomo, ossidiana. Uomini e merci tra Oceano Indiano e Mediterraneo, Roma 1996, 167–202, soprattutto per gli aspetti economici; per le questioni contabili e fiscali, ancora De Romanis, Commercio (n. 8) 11–60, che rimane la migliore base per la comprensione dei calcoli della time. Più sinteticamente D. Rathbone, The ‘Muziris’ papyrus (SB XVIII 13167): financing roman trade with India, in BSAA 46 (2000) (Alexandrian Studies II, in honour of Mostafa el-Abbadi), 39–50.
[24] La corretta posizione è visibile sull’immagine accessibile all’indirizzo http:// aleph.onb.ac.at/F/?func=find-c&ccl_term=WID%3DRZ00001642&local_base=ONB08. Restauri successivi all’edizione hanno per altro comportato la perdita di un frammento sulla sinistra delle ll. I.6–7; alcuni frammenti minimi sono stati collocati arbitrariamente a riempire piccole lacune in qua e in là; per l’attuale erronea posizione della parte inferiore sinistra, vedi più avanti n. 35.
[25] Ciò era stato rilevato anche da Rathbone, The ‘Muziris’ papyrus (n. 23) 43, che per la menzione della tetarte in I.8 metteva questa cifra in relazione con il calcolo di questa imposta; la falsa lettura dell’ed. pr. per la quantità totale di I.5 gli impediva però di sviluppare il ragionamento e di riconoscere i rapporti esatti tra le cifre.
[26] 105 talenti × 60 = 6.300 mine + 13 = 6.313 mine; 26 talenti × 60 = 1.560 mine + 18 ¼ = 1.578,25; 6.313 : 1.578,25 = 4.
[27] 17 talenti × 60 = 1.020 mine + 33 = 1.053 mine : 4 = 263 ¼ mine = 4 talenti e 23 ¼ mine.
[28] De Romanis, Commercio (n. 23) 30–36, Rathbone, The ‘Muziris’ papyrus (n. 23) 45–46.
[29] Come aveva compreso Rathbone, The ‘Muziris’ papyrus (n. 23) 45–46.
[30] Il fatto che poi questa parte degli arabarchi sia in I.8 trattata come le altre quantità di questa sezione, e sommata in I.6 alla tetarte, non significa che essa fosse una quantità reale, corrispondente davvero a quello che è registrato sul papiro. Si è visto che anche quella indicata per la tetarte è solo la quantità teorica, di fatto inferiore a quella che è stata prelevata. Al contrario, per questa ‘parte degli arabarchi’ la l. I.8 riporta una quantità che poteva essere leggermente superiore al peso reale. Per conoscere la quantità che realmente si nasconde dietro ai 26 talenti e 30 mine di I.6, dobbiamo sottrarre dalla quantità reale di partenza di 105 talenti e 13 mine (= 6.313 mine) la quantità che il mercante utilizza per il calcolo del valore della sua parte, e cioè 76 talenti e 41 mine (= 4.601 mine). Quello che rimane è 28 talenti e 32 mine (= 1.712 mine). Questa quantità si compone della ‘parte degli arabarchi’, valutata in 11 ¾ mine in I.8, ma probabilmente di 11 ½ mine reali; e dei rimanenti 28 talenti e 20 ½ mine che rimangono — uguale poi come essi sarebbero stati ripartiti tra fisco e amministratori — agli arabarchi a titolo di tetarte in luogo dei 26 talenti e 18 ¼ mine che si sarebbero ottenuti dividendo correttamente la quantità totale e che si trovano registrati in I.9. Ma tutto questo è solo una nostra curiosità. Il mercante, o chi per lui ha redatto il conto, è interessato solo a quello che gli rimane per la prosecuzione dei suo affari, ed è questa quantità che egli ora si preoccupa di riportare alle sue reali dimensioni. Ciò che è rimasto agli arabarchi, egli può registrarlo semplicemente secondo le quantità nominali, che poi somma senza preoccuparsi se esse siano dello stesso tipo e commensurabili, quantità reali, o ad esse superiori o inferiori.
[31] Non è possibile neppure pensare che si trattasse di una tassa calcolata prima secondo la quantità in natura, e poi pagata in denaro; la quantità rimarrebbe materialmente al mercante che per questo ne calcolerebbe il valore in denaro e lo sommerebbe a quello dei suoi ¾ di carico. La colonna I mostra infatti che questa ‘parte degli arabarchi’ è sommata, in natura, alla tetarte. Il che significa che le merci seguono la tetarte, e il suo valore in denaro segue il mercante.
[32] Vedi sopra il mio commento a II.41.
[33] Non entro nella questione posta da P. Van Minnen, Money and Credit in Roman Egypt, in W. V. Harris, The Monetary Systems of the Greeks and Romans, Oxford 2008, 237–238, di cosa poi lo stato facesse con questi prodotti, e se essi non fossero piuttosto di nuovo riscattati dai mercanti con pagamenti in denaro: non mi sembra ci siano testimonianze decisive per rispondere a queste domande. Il modo di procedere del nostro conto presuppone comunque che la divisione fosse fatta in modo da rendere almeno possibile una effettiva riscossione della tetarte in prodotti piuttosto che in denaro. D’altra parte, se la tetarte fosse stata riscossa in denaro, perché mai il nostro conto calcolerebbe il valore soltanto dei ¾ del carico rimasti al mercante? Logico e più semplice sarebbe stato fin dall’inizio convertire tutto in denaro, e poi dividere la somma di denaro nelle due parti da ¼ e da ¾, secondo lo stesso procedimento che avrebbe dovuto essere stato seguito dagli agenti del fisco. In più il mercante, al quale sarebbe rimasto materialmente l’intero carico, avrebbe dovuto aver interesse a conoscere il valore di tutto quanto egli aveva a disposizione per la prosecuzione dei propri affari. Lo stesso vale per il creditore: egli, che in caso di mancata restituzione del prestito si sarebbe rivalso sulla merce e avrebbe pagato la tetarte (recto l. 18), avrebbe avuto bisogno di conoscere non solo il valore di quanto gli sarebbe spettato, ma anche — o ancor più — la somma da pagare a titolo di tasse. Da un punto di vista pratico, un pagamento in denaro avrebbe comportato per i mercanti la grossa difficoltà di dover sborsare una somma pari a ¼ del valore del loro carico — del valore sul mercato occidentale, non del prezzo da loro pagato in India — proprio alla fine del viaggio: nel momento di maggiore esaurimento dei loro mezzi finanziari, e prima di vendere il carico. Vedi anche più avanti n. 61.
[34] In ogni caso anche pensando a tessuti, la seta — nel Periplus Maris Erythraei 56.9 ss. tra le merci esportate dai porti dell’India meridionale come Muziris — sarebbe stata da escludere. Il prezzo di 70 dracme la mina corrisponde al 70 % di quello dell’avorio, di 100 dracme per mina. L’Edictum de Pretiis dà, a fronte di un prezzo di 150 denari la libbra per l’avorio in 16.10a, 12.000 denari per la libbra di seta — non tessuta: ma il costo del lavoro influisce in maniera trascurabile sul prezzo di un prodotto del genere — in 23.1a. Una libbra di seta costa insomma quanto 80 libbre di avorio, mentre nel nostro papiro una libbra di schidai costa quanto 0,7 libbre del secondo materiale. Che il prezzo della seta si fosse moltiplicato di 114 volte in relazione all’avorio è difficilmente immaginabile. Risultati analoghi si ottengono confrontando il prezzo delle schidai con quelli di altri prodotti. Un prodotto tessile che nell’Ed. de pr. ha un prezzo uguale a quello dell’avorio lo si trova nella sezione delle lane a 25.12, dove 150 denari sono dati per una libbra di lana αρεια, da identificare probabilmente con il cotone: il capitolo delle lane non raccoglie soltanto lana, e dopo una prima parte con le lane di razze di pecore particolari — dalla modenese a quella delle Asturie — esso dà i prezzi di due lane comuni: a l. 8 la “lana ottima, di media qualità, lavata”, a 50 denari la libbra; e poi a l. 9 “tutte le altre lane, lavate”, a 25 denari. Implicitamente l’espressione “tutte le altre lane” fa intendere che con questa linea la parte dedicata alle lane propriamente dette, di pecora, è terminata. Quelle che seguono non sono propriamente lane: la lana marina o bisso ricavata dai filamenti dorsali della conchiglia pinna nobilis, a l. 10; la lana di pelo di lepre a l. 11; quindi la nostra “lana aria” a l. 12 e infine una lana che diventa Atrebatica solo con l’aggiunta di un α iniziale nell’iscrizione, che in realtà ha solo τρεβατικῆϲ.
[35] L’immagine digitale attualmente (2011) visibile all’indirizzo http://aleph.onb.ac.at/F/ ?func=find-c&ccl_term=WID%3DRZ00001642&local_base=ONB08 presenta una situazione delle linee falsata da un inesatto restauro effettuato in anni recenti: il frammento con la parte sinistra delle linee II.45 ss. è stato posizionato troppo a sinistra, così che la linea II.45 — ma anche quelle che seguono — sembra essere in ekthesis rispetto alle precedenti. Non in ekthesis è in ogni caso la linea II.44: quella che, con la voce ϲχιδῶν dà inizio a questa parte. La situazione corretta è visibile invece sulla foto pubblicata con l’ed. pr.
[36] Harrauer, Sijpesteijn, art. cit. (n. 1) 149 n. a l. 26: “Der Grund für den neuerlich notierten Zollbetrag für das Elfenbein ist nicht ersichtlich. Man kann vage vermuten, daß zur besseren Übersichtlichkeit die Wiederholung geschrieben ist, da der Betrag in Z. 15 nicht hervorsticht.”
[37] De Romanis, Commercio (n. 23) 35 n. 97; Rathbone, The ‘Muziris’ papyrus (n. 23) 43.
[38] L’ed. pr. aveva qui μ̣ν̣(ῶ̣ν̣) (δραχμῶν) ψοα, difficile da spiegare.
[39] Correttamente De Romanis, Commercio (n. 23) 32, osserva che si tratta di prezzi tondi, che dovevano essere tratti da un tariffario, e in particolare di prezzi ‘greci’, in dracme per mina.
[40] L. Taborelli, Aromata e medicamenta exotica in Plinio, Seconda parte, Athenaeum 82 (1994) 131. Prezzi ricavati da una tariffa ufficiale sembrano essere anche quelli indicati dallo stesso Plinio per il nardo: Taborelli cit. (n. 40) 130.
[41] PME 56: φέρεται πέπερι, μονογενῶϲ ἐν ἑνὶ τόπῳ τούτων τῶν ἐμπορίων γεννώμενον πολύ, λεγομένῃ Κοττοναρικῇ· φέρεται δὲ καὶ μαργαρίτηϲ ἱκανὸϲ καὶ διάφοροϲ καὶ ἐλέφαϲ καὶ ὀθόνια Ϲηρικὰ καὶ νάρδοϲ ἡ Γαγγιτικὴ καὶ μαλάβαθρον ἐκ τῶν ἔϲω τόπων εἰϲ αὐτὴν καὶ λιθία διαφανὴϲ παντοία καὶ ἀδάμαϲ καὶ ὑάκινθοϲ καὶ χελώνη ἥ τε Χρυϲονητιωτικὴ καὶ ἡ περὶ τὰϲ νήϲουϲ θηρευομένη τὰϲ προκειμέναϲ αὐτῆϲ τῆϲ Λιμυρικῆϲ.
[42] Il prezzo di questo prodotto è indicato da Plinio Naturalis Historia XII 129: dopo aver detto tra le altre cose che il malabathron indiano è quello migliore, egli dice che il prezzo è prodigioso, poiché va da 1 a 300 denari la libbra, e poi aggiunge che le foglie sono vendute a 60 denari la libbra. Prezzi diversi si trovano riportati da L. Casson, The Periplus Maris Erythraei, Princeton 1989, p. 242, che attenendosi alla vulgata ritiene che le foglie avessero prezzi da 1 a 300 denari la libbra, mentre quello di 60 denari sarebbe il prezzo dell’olio di malabathron. Ma la lezione oleum al posto di folium in Plinio risulterebbe da correzioni moderne non sostenute dalla tradizione manoscritta, che dà invece i valori che ho indicato, se mai con varianti di significato relativo, del tipo 400 al posto di 300, o 40, 50 o 70 al posto di 60. I prezzi di Plinio significherebbero 1.950 dracme la mina per il malabathron della migliore qualità, e 390 dracme la mina per le foglie: siamo su ordini di grandezza completamente diversi da quelli del prodotto del nostro papiro. D’altra parte alcune dichiarazioni di prezzi del IV secolo danno dati meno distanti: in P.Oxy. LIV 3731.9 e 11 (c. 310–311), la corporazione dei myropolai dichiara per pepe e malabathron lo stesso prezzo di 1 talento per libbra. Poco dopo, nel 312, P.Oxy. LIV 3733.8 e 10 dà un prezzo per il malabathron di 2 talenti per libbra: doppio rispetto a quello del pepe, rimasto invariato. Più tardi, nel 327, P.Oxy. LIV 3766.84 e 86 mostra un notevole aumento del malabathron rispetto al pepe: 50 talenti per la libbra di malabathron contro i 12 del pepe. La differenza rimane comunque assai più contenuta di quella che sembrano lasciar intravedere i dati di Plinio.
[43] Periplus Maris Erythraei 56: πλεῖ δὲ εἰϲ τὰ ἐμπόρια ταῦτα μέ<γι>ϲτα (? per la lettura vedi De Romanis, Cassia, cinnamomo [n. 23] 178–180 n. 40) πλοῖα διὰ τὸν ὄγκον καὶ τὸ πλῆθοϲ τοῦ πιπέρεωϲ καὶ τοῦ μαλαβάθρου.
[44] Vedi sopra n. 42.
[45] Poche delle menzioni di kistai nei papiri sembrano far riferimento ad un contenitore di capacità più o meno determinata. E quelle poche non danno indicazioni per stimarne la misura. In ogni caso in P.Lond. VII 1940.62 (Philadelphia c. 257 a.C.) una kiste è usata per sigillarvi una mezza artabe da portare come campione al sitologo: dunque — considerato che siamo nel III a.C. — una quindicina o una ventina di litri. Altre indicazioni sono in BGU II 544 (Arsinoite 138–161): tra le cose trasportate da una carovana di cammelli ci sono a ll. 6–8 due kistai che contengono prodotti tessili per un peso di 3 talenti e 15 mine: 1 talento e 37,5 mine per kiste; a ll. 15–17 una kiste contiene un talento e 30 mine di lino; se utilizzate per materiali più pesi anche il peso ovviamente aumenta: una kiste di chiodi di legno o cavicchi pesa 3 talenti e 30 mine a ll. 18–20; 3 kistai di chiodi di rame pesano 5 talenti e 40 mine a ll. 9–11: mediamente 1 talento e 8 mine a kiste; 11 kistai di chiodi di ferro per 22 talenti e 11 mine a ll. 11–12: 2 talenti e 1 mina a kiste. Lasciando da parte i prodotti metallici più pesanti e senza entrare nella discussione del tipo di talento usato, ci si può orientare intorno a pesi tra una e qualche decina di kg per prodotti come il grano. D’altra parte Plinio dà nella Naturalis Historia XII 42 ss. prezzi di 100 denari la libbra per le spighe, e di 40, 60 e 75 denari per le foglie del nardo, secondo le dimensioni. Tradotti in dracme, si tratterebbe di 400 dracme la libbra per le spighe, e tra 160 e 300 dracme per le foglie. Le 4.500 dracme per kiste del nostro papiro implicherebbero tra le 11,25 e le 28,125 libbre per kiste, e cioè tra c. 3,6 kg e c. 9 kg. Certamente non sappiamo in che rapporto il prezzo del nostro papiro stesse con quelli dati da Plinio; ma il dato non sarebbe in contrasto con il peso ipotizzato per la kiste di grano, poiché le foglie di una spezia sono molto più leggere.
[46] Nel calcolare il rapporto tonnellata – artabe di 1 : 25 tratto l’artabe per quello che è, e cioè come misura di volume, e considero un volume di c. 40 litri. Una misura di volume è in sé anche la tonnellata, riferita ad un metro cubo d’acqua. Anche nel caso di carichi a peso specifico più elevato, per 1.000 kg dei quali sarebbe stato sufficiente uno spazio minore del metro cubo, il volume interno della nave — che poteva anche rimanere in parte inutilizzato — non poteva comunque essere inferiore a quello del corrispondente peso di acqua: altrimenti la nave sarebbe andata a fondo per il principio di Archimede. Per le questioni relative ai diversi concetti di tonnellaggio, portata etc., vedi F. C. Lane, Tonnages, Medieval and Modern, The Economic History Review 2nd Ser. 17 (1964) 213–233. Vedi anche la mia discussione relativa a tonnellaggi, portate, volumi e pesi in CPR XXX 1 introd. p. 93–96. Nel nostro caso per la conversione è da tenere presente che, avendo il pepe nero in grani un peso specifico sui 500–550 g per litro, 138.915 kg di pepe avranno occupato uno spazio maggiore, intorno ai 260 m3, corrispondente a c. 6.500 artabai. Con il resto del carico, almeno in parte costituito da prodotti più pesi, non si sarà arrivati oltre le 8.000–9.000 artabai.
[47] L. Casson, Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton 1971, 164. Questi e altri dati dello stesso genere da altri documenti sempre del periodo tolemaico sono raccolti in I. J. Poll, Ladefähigkeit und Größe der Nilschiffe, APF 42 (1996) 127–138, in particolare 135–138. Navi di grosse dimensioni sono attestate comunque anche per il periodo romano: così le 8 navi per un totale di 40.000 artabai — per una media di 5.000 artabai — di P.Oxy. X 1259, del 212 (G. Bastianini, J. E. G. Whitehorne, Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt, Firenze 1987 [Pap.Flor. 15], 96). Ad una sola nave per una portata di 12.000 artabai pensa Poll, Ladefähigkeit (n. 47) 138 per SB VI 9088.3, del III d.C. dall’Ossirinchite. Del resto in SB XVIII 13167 si dice esplicitamente che le merci saranno caricate su un ποτάμι̣ον ἀϲφαλὲϲ πλοῖον, non ποτάμια ἀϲφαλῆ πλοῖα, e che il mercante accompagnerà il carico: il che sembra implicare che sul Nilo ci fossero navi in grado di trasportare carichi di questo genere.
[48] Vedi Casson, Ships (n. 47) 189–190.
[49] Un esempio è la ricostruzione di una nave da carico araba lunga 18 metri, cucita secondo i metodi tradizionali in base ad un relitto del IX secolo, e che ha percorso in 28 giorni le 1.300 miglia dall’Oman all’India meridionale, per poi proseguire fino a Singapore: http://www. jewelofmuscat.tv (2011).
[50] Casson, Ships (n. 47) 170–173.
[51]
Cfr. anche N. Litinas,
Hierakapollon, the Titles of Panos Polis and the Names in
-Apollon
, Anc. Soc. 37 (2007) 100–102.
[52] Vedi Casson, Ships (n. 47) 360, e indice 439–441.
[53] R. A. Coles in Poll, Ladefähigkeit (n. 47) 134 n. 17.
[54] Thür, Hypotheken-Urkunde (n. 2) 233 traduce con “exportierten Ladung” e a p. 239 commenta: “Aus dem Perfekt ἐκπεπλευκότων (Z. 27) wird klar, dass die Aufstellung den Export aus Indien, also den Import in das Imperium Romanum betrifft.” De Romanis, Commercio (n. 23) 57 traduce direttamente con “importate”.
[55] Così anche nella letteratura: Stephanus, ThGL III 533s. ha “Enavigo [Gl.], Solvo, Vela facio”; “Exeo e portu”; Tucidide 2.69 oppone ἐκπλεῖν e ἐϲπλεῖν: μήτ᾽ ἐκπλεῖν μηδένα, μήτ᾽ ἐϲπλεῖν, “pro Neminem exire, nec intrare”. Ancora Tucidide 2,93: “Τοῦ μὴ ἐϲπλεῖν Μεγαρεῦϲι, μήτ᾽ ἐκπλεῖν μηδέν, pro Ne quid importaretur Megarensibus, nec exportaretur”, dove i verbi per importare ed esportare si intendono in relazione ad un luogo o a delle persone che devono essere menzionate, i megaresi.
[56] Art. cit. (n. 1) 150.
[57] Diffusamente su arabarchia, arabarchi e appaltatori dell’arabarchia, F. Burkhalter-Arce,Les fermiers de l’arabarchie: notables et hommes d’affaires à Alexandrie, in: Alexandrie: une mégapole cosmopolite. Actes due 9ème colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 2 & 3 octobre 1998 , Paris 1999, 41–54; più in generale, con ampia trattazione delle imposte doganali, A. Jördens, Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit: Studien zum praefectus Aegypti, Stuttgart 2009 (Historia Einzelschriften 175), 355–370.
[58] Ad una funzione di controllo delle merci pensava già Jördens, Verwaltung (n. 57) 358 n. 10, la quale, considerando la parte degli arabarchi come una tassa, ne poneva la riscossione a Berenice. Cfr. anche la sintesi a p. 368.
[59] Che a Copto non ci fossero realmente dei funzionari che avevano la qualifica di arabarchi, è qui un problema secondario. Jördens, Verwaltung (n. 57) 359–360 osserva che nell’uso comune il titolo poteva essere attribuito anche a funzionari subalterni che agivano per conto degli arabarchi propriamente detti: funzionari che certamente saranno stati nell’amministrazione dei magazzini doganali dei quali parla anche il recto del nostro papiro. Né è una testimonianza per escluderlo il fatto che la tariffa di Copto parli di affittuari dell’ apostolion, da versare poi all’arabarchia. L’apostolion è cosa diversa dalle tasse doganali, e l’iscrizione mostra comunque che Copto rientrava nelle competenze dell’arabarchia. Per Pelusio del resto l’arabarchia, dopo una fase in cui essa era data in appalto, va o torna sotto la gestione diretta dell’amministrazione statale, Jördens, Verwaltung (n. 57) 369–370. Non sappiamo come queste cose si fossero evolute a Copto.
[60] Difficile sarebbe stato invece far scomparire parte della merce durante l’attraversamento del deserto, tra Berenice e Copto. I contrabbandieri avrebbero dovuto comunque far entrare le merci nella valle del Nilo passando per i punti in cui arrivavano le piste che attraversavano il deserto orientale. Copto era un ‘porto’ di arrivo per chi veniva dal deserto, come Berenice o Myos Hormos lo erano per chi arrivava dal mare. D’altra parte il mercante di SB XVIII 13167 si impegna nel contratto sul recto a trasportare le merci attraverso il deserto μετὰ παραφυλακῆϲ καὶ ἀϲφαλείαϲ. È ben possibile, come ritiene D. Rathbone, Koptos the Emporion. Economy and Society, I–III AD, in Topoi Suppl. 3, Autour de Coptos. Actes du colloque organisé au Musée des Beaux-Arts de Lyon (17–18 mars 2000), Lyon 2002, 185, che questa sorveglianza fosse organizzata dallo stato poiché anche gli arabarchi, come i mercanti, avevano interesse a che le merci arrivassero senza perdite a destinazione.
[61] Questa ricostruzione si accorda benissimo con il ruolo di Copto come emporio e posto di dogana per le merci provenienti dall’India, così come esso è discusso da F. Burkhalter-Arce, Le « Tarif de Coptos ». La douane de Coptos, les fermiers de l’apostolion et le préfet du désert de Bérénice, in Topoi Suppl. 3, Autour de Coptos (n. 60), 199–223, in particolare 202–205. Anche Burkhalter, Les fermiers (n. 57) 45–46, pur considerando la Hermapollon come la nave che aveva trasportato le merci dall’India, pensava ad un calcolo e poi pagamento della tetarte in due fasi distinte: “Cette taxe était calculée par les douaniers lors du débarquement des marchandises sur le sol égyptien. (...) Il est clair que les marchands qui revenaient de l’Inde ne pouvaient pas disposer de telles sommes en rentrant en Égypte, et que les taxes étaient payées à Alexandrie. Les marchandises étaient acheminées sous scellés, et aux frais des particuliers, jusqu’à leur destination finale.” Idem D. Rathbone, Koptos (n. 60) 183 s., — che pure ritiene il documento scritto in Alessandria —: “The shipment in the papyrus was to be bonded in the ‘public tax-receiving warehouses’ at Koptos (...), and then sent down the Nile to Alexandria to the « warehouse for receiving the quarter-tax », where the quarter-tax was, in this case, to be paid. The tax was paid in kind. It seems that Koptos was where a merchant could first have the tax assessed and clear his goods through customs, although he was probably still responsible for delivering the government’s quarter of the goods to Alexandria.”